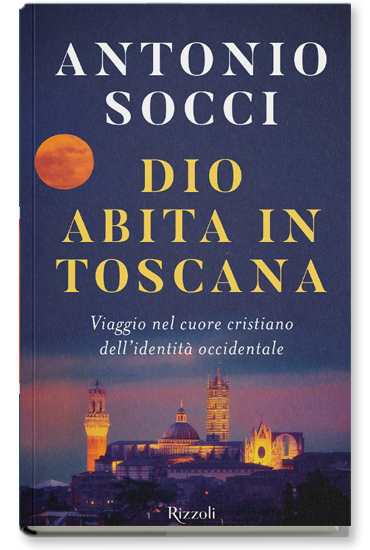D’Alema col mito del Cav
Chi scriveva queste cose nel luglio 1997?
Il Pds, come “ceto politico”, è “un cane morto”, “il suo stato è sotto ogni punto di vista desolante: il gruppo dirigente nazionale è in buona parte formato da inetti, i gruppi dirigenti locali sono del tutto al di sotto della funzione”. Il partito “non può essere rianimato”. Rileggiamo: Inetti.
Chi formulava questi “lusinghieri” giudizi? Fu Berlusconi? O Feltri? No. Furono scritti, nero su bianco, dalle due menti dello staff di D’Alema, cioè Claudio Velardi e Fabrizio Rondolino, in un documento top secret che sembra un po’ il canovaccio della strategia dalemiana in quegli anni (è venuto alla luce grazie ad un libro di Alessandra Sardoni, “Il fantasma del leader”).
Naturalmente D’Alema negli stessi giorni, in pubblico, diceva l’esatto contrario, assicurava l’ottima salute del suo schieramento, che aveva in mano l’Italia e si mostrava preoccupato “dalla cattiva salute dell’altro Polo, perché per fare il bipolarismo bisogna essere in due.
Il fatto è che abbiamo una destra scarsamente credibile” (Il Tempo, 5.11.97), “Berlusconi perde la testa, a ogni sua sortita perdono voti” (L’Unità, 14.11.97). E’ ovvio che in pubblico facesse propaganda. Ma nel caso di D’Alema la recita delle dichiarazioni viene solitamente allestita nel teatro del disincanto, che sorge nel deserto del fallimento epocale comunista. E ha un senso particolare. Una volta ebbe a dire: “Forse dobbiamo pensarci come una generazione di transizione. Io ho fatto in tempo a mettermi il fazzoletto rosso sotto le foto di Stalin e ora sono vice-presidente dell’Internazionale socialista. E’ inevitabile che viva tutto con un certo disincanto”.
Nel disincanto la sola cosa che resta è il potere, ambìto in forza di un mai spiegato complesso di superiorità o di un misterioso destino.
E questa sembra in effetti la stella polare dalemiana. Infatti i due strateghi, nel piano redatto per il Lider Massimo, continuavano chiedendosi cosa fare di quel ferrovecchio che era il Pds e rispondevano delineando la “staffizzazione del Pds”.
In pratica: “dobbiamo pensare il Pds come una delle componenti del comitato elettorale di Massimo D’Alema”. Per arrivare dove? “Più che Palazzo Chigi, il Quirinale”.
In effetti ci provò… Questo documento – puntato sulle smisurate ambizioni personali del Lìder Massimo – riletto oggi si presta a mille ironie. Tante sono le “cantonate sesquipedali” e le “previsione sbagliate” – come ha riconosciuto lo stesso Rondolino – che diventa facile comprendere perché sono andati incontro alla disfatta (dal momento che D’Alema era il pilastro del centrosinistra).
Ma questa nota politica è pure un memorabile reperto antropologico, perché documenta il sorprendente vuoto di idee e di ideali in cui navigava (e naviga) la classe dirigente post-Pci. E in cui si è espressa sia la proverbiale spavalderia politica di D’Alema, sia la sua ambizione personale quirinalizia.
Sorprende sinceramente la povertà culturale di questa analisi se confrontata con quelle che sfornava il Pci che erano magari ideologiche, ma profonde (avvertivi alcune letture serie e una notevole comprensione dei processi sociali). La centralità era del Partito principe. Qui invece c’è solo il principino, D’Alema. Ed è tutto. Della proverbiale “sufficienza” di scuola dalemiana, condita con tatticismo machiavellico, c’è una certa documentazione in queste pagine.
Il “disprezzo” per Rifondazione è definito “sacrosanto” tuttavia “dobbiamo servirci di Rifondazione esattamente come ci serviamo di Dini o di Di Pietro”. L’operazione Di Pietro, cooptato nel centrosinistra, è “morotea nel senso dell’inclusione all’interno del sistema di una scheggia potenzialmente eversiva”. Veltroni è liquidato come un impasto di vecchi salotti intellettuali e democristianeria.
Del resto D’Alema non ha mai nascosto il suo complesso di superiorità nel centrosinistra. Quello che invece queste pagine sembrano rivelare di nuovo è un fantastico complesso di inferiorità, o almeno l’inconfessata, sviscerata ammirazione per un modello che si cerca in ogni modo di imitare per poter arrivare al Quirinale. Ed è un “mito” che sorprende: Berlusconi.
Sì, proprio lui, l’arcinemico. Il piano strategico dello staff dalemiano lo indica come modello (“Come il Berlusconi dei tempi d’oro, D’Alema deve rivolgersi agli italiani”), copia i suoi contenuti (“per fare dell’Italia un Paese moderno dobbiamo scontrarci con il sindacato” che “è l’ultimo baluardo della conservazione”: D’Alema in realtà uscì a pezzi dal confronto con la Cgil di Cofferati).
Ma ancor più lo staff dalemiano mostra che il berlusconismo – che in pubblico si depreca, quello dell’ “immagine” – è ormai interiorizzato: “dobbiamo coltivare l’immagine ‘presidenziale’ di D’Alema”, addirittura per portarlo al Quirinale si punta su argomenti come la sua giovane età e la famiglia (“l’immagine della first-family, giovane e bella” che “è un fattore essenziale nell’elezione diretta”).
Infine si prospetta su una strategia di “seduzione” dei media che è esattamente quella oggi rimproverata a Berlusconi: “non dobbiamo cambiare i giornali; dobbiamo prima di tutto sedurre i giornali per potercene servire” e per esempio “portare alla guida del Corriere e di Repubblica due direttori di garanzia, avversi al qualunquismo pettegolo che costituisce la cifra di questi due quotidiani”.
Fra le indicazioni per la costruzione “berlusconiana” del Presidente D’Alema leggiamo: “lavorare sulle fotografie (in famiglia, a casa, al mare), sui media di target medio-basso, sulla tv popolare (Costanzo)” e “poi dovremo studiare qualche evento” per questa nuova immagine: “la ricetta di cucina è l’esempio più immediato”. E arrivò così il famoso risotto in tv….
Come tutte le imitazioni malriuscite fa sorridere questo eccesso di costruzione televisiva del personaggio. Per esempio si arriva a prescrivere al Lìder Massimo: “il corpo dev’essere meno rigido, le mani devono muoversi con più libertà e familiarità: anche la testa può muoversi più liberamente: un movimento dolce dal basso in alto, come di un gatto che fa le fusa, è un esempio possibile”.
A D’Alema fare le fusa non è bastato per arrivare al Quirinale. Ma la causa di questo fallimento, nell’imitazione del modello berlusconiano, appare molto evidente. Infatti il motivo per cui lo staff dalemiamo indicava il Quirinale come meta è esattamente quello per cui a Berlusconi non piace: lì si lavora poco.
Si legge nel testo top secret: “i ritmi di lavoro di Palazzo Chigi sono massacranti” e sebbene D’Alema – dicono i due collaboratori – sia “un buon lavoratore” a certe sue “fasi intensive si affiancano fasi di inattività pressoché totale”, perciò meglio il Quirinale.
Forse il motivo per cui i “Berlus-cloni” di Sinistra sono usciti con le ossa rotte da 15 anni di scontro col Berlusconi autentico è anche questo: il Cav lavora come un pazzo. Ma l’altro motivo sta proprio nel fatto che interiormente ammiravano il Nemico che indicavano alla pubblica esecrazione. Cioè partivano culturalmente già sconfitti (diceva Gaber: “non temo Berlusconi in sé, ma Berlusconi in me”).
Questo è il bilancio del passato. Ma a volte ritornano. Anzi, questa vecchia classe dirigente di sconfitti – in primis il ragazzo Massimo (“ho fatto in tempo a mettermi il fazzoletto rosso sotto le foto di Stalin”) – già affila le lame per riprendere la guida. E condurre la sinistra verso nuove, gloriose disfatte.
Si può simpatizzare per Berlusconi o no, ma bisogna riconoscere che il Cav ha letteralmente asfaltato la Sinistra riuscendo addirittura nell’impresa storica di berlusconizzare i post-Pci e convincere gli elettori a cancellare i rimanenti comunisti dal parlamento italiano.
A questo punto forse al Pd resta solo una strada: riconoscersi “berlusconiani di sinistra”, votare il Cavaliere al Quirinale e ripartire da zero con una nuova classe dirigente che si confronti con un nuovo Pdl.
Fonte: © Libero – 09 giugno 2009