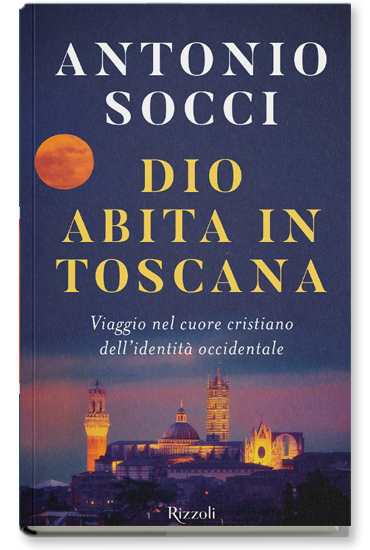UN GRANDE PITTORE (ATEO) DA SCOPRIRE, LA PREGHIERA PER IL FIGLIO E IL CROCIFISSO COME EX VOTO: “MI HAI ASCOLTATO CRISTO, GRAZIE”.
C’è un pittore italiano che probabilmente è fra i maggiori del Novecento, ma non è affatto conosciuto se non fra gli addetti ai lavori. Infatti il 2018, che era il centenario della nascita, è trascorso senza che sia stato ricordato in modo particolare.
Del resto la sua pittura – banalmente ed erroneamente classificata come naïf – non nasce dallo studio, dall’accademia, ma dalla scuola della vita. Si potrebbe anche dire dalla vita della scuola visto che – di professione – per diversi anni ha fatto il bidello e proprio in quel contesto lavorativo ha iniziato a dipingere: si tratta di Gino Covili.
Modenese di Pavullo nel Frignano, Covili nasce nel 1918 in una famiglia modesta, segnata dall’assenza del padre (un violinista trasferitosi in Francia). Perciò fin da ragazzo – fatte le elementari – deve sgobbare prima come garzone, poi come operaio.
Partecipa alla guerra, come militare, e poi alla Resistenza sulle colline emiliane, non per particolari convinzioni politiche, ma per sfuggire alla deportazione in Germania. E’ durante la vita partigiana che maturerà le sue idee e la sua militanza nel Pci. Finito il conflitto mondiale, Covili va a lavorare come manovale e mette su famiglia.
Nel 1950 viene assunto come bidello nella scuola di Pavullo, un mestiere che gli consente di trovare il tempo per la sua grande passione: il disegno e la pittura.
Dopo una ventina di anni – e dopo le prime mostre a Bologna e Milano – comincia ad essere conosciuto ed apprezzato e può dedicarsi completamente alla creazione artistica.
Il suo è un caso singolare perché pur essendo venuto in contatto con l’ambiente intellettuale (da Luchino Visconti a Cesare Zavattini, da Rafael Alberti a Carlo Levi), rimane fuori dal salotto dell’alta cultura. Resta un uomo del popolo, non dell’élite.
Eppure il suo valore è riconosciuto. Nel 2002 alla Mostra internazionale del cinema di Venezia, Vittorio Storaro presenta il film “Gino Covili. Le stagioni della vita”. E nel 2005 addirittura il Parlamento italiano espone la mostra “Storaro-Covili: il segno di un destino” (fra l’altro il pittore morirà proprio a pochi giorni dall’inaugurazione).
Cionondimeno il suo nome e la sua pittura devono ancora essere scoperti dal grande pubblico. Lo stesso mondo intellettuale della Sinistra sembra ignorarlo. Forse perché non è un intellettuale organico. La star di quel mondo – e di quei salotti – è stato per decenni Renato Guttuso.
Ma chi si avvicina, con attenzione e senza giudizi precostituiti, alla pittura di Covili si rende conto che la sua arte non ha davvero nulla da invidiare a quella di Guttuso. E’ – a mio parere personale – molto più potente.
E’ la bellezza primigenia della vita del popolo che tracima dalle sue tele ed ha la stessa potenza che traspare nelle opere di Wiligelmo, il grande scultore che attorno al 1100 realizzò gli straordinari rilievi, i capitelli e le metope del Duomo di Modena, la città di Covili.
Questo grande maestro del romanico – il cui capolavoro è la rappresentazione della Genesi (attualmente sulla facciata del Duomo) – nell’XI secolo riuscì a dare al marmo le potenti forme umane di un popolo che stava uscendo dall’informe, un popolo che stava riconquistando una sua lingua e una sua identità.
Covili ha come tema fondamentale il suo mondo paesano, contadino e popolare, che rappresenta in quel dopoguerra in cui la civiltà contadina, dopo dodicimila anni, stava per essere spazzata via dall’industrializzazione, con una mutazione antropologica e spirituale che solo Pier Paolo Pasolini intuì (e denunciò) drammaticamente, con accorato dolore.
Per questo Pasolini fu etichettato – dai critici marxisti – come “populista” e nostalgico della civiltà contadina. Vincenzo Cerami ha osservato: “Pasolini è stato un populista, questo è vero. Lui stesso l’ha detto più volte. Ma il suo populismo era premarxiano, di sostanza cristiana, creaturale. Mentre il populismo fascista è di derivazione marxista, ereditato dal populismo russo dell’Ottocento”.
Questa stessa definizione del “populista” Pasolini vale per la pittura di Covili la cui bellezza sta soprattutto nel movimento di quelle figure arcaiche che sembrano emergere potentemente dalla terrastessa come Wiligelmo le faceva emergere dalla pietra e dal marmo.
Basti ricordare l’opera più nota di Covili, “L’ultimo covone” o “Il mietitore”, ma anche “Festa” e “Il seminatore” (molte sue opere si possono vedere nella sua casa-museo di Pavullo).
Uomini che lavorano nel calore delle campagne, che mangiano o discutono alle tavole di legno, che camminano sulle vie spazzate dal vento, sommerse dalla neve, nei campi pieni di grano, che ballano nelle feste della comunità paesana e si avventurano nelle foreste popolate di animali.
Ciro Tarantino ha scritto che “la pittura di Covili nel suo complesso può essere letta in chiave di resistenza. La Resistenza esplicita della sua esperienza sui monti del Frignano e dei suoi disegni partigiani, quella del mondo comunitario e contadino che è arrivato a ‘l’ultimo covone’ e resiste alla propria dissoluzione, quella dell’uomo che resiste alla fatica e alla natura, e talvolta perde, la vita come ne ‘la morte nella cava’, quella dei paesi che sopravvivono nella loro pietra all’abbandono, all’emigrazione, naturalmente quella di tutti gli esclusi, degli spossati, degli strematidelle sue tele, e anche la sua, che si ritiene ormai minoritario nella necessità di tutte queste resistenze”.
E’ anche il mondo appenninico, contadino ed emiliano di Giovanni Lindo Ferretti (le sue pagine sarebbero perfette per illustrare le tele di Covili) e, del resto, anche la vicenda umana e artistica di Covili ritrova, alla fine, uno sfondo cristiano.
L’ha raccontato, in un’intervista, il figlio Vladimiro, che è direttamente coinvolto perché proprio lui, nel febbraio 1992, fu vittima di un grave incidente stradale che lo precipitò in uno stato di coma, in cui restò per un mese.
Il padre corse subito in ospedale, ma poi “si chiuse nel suo studio” racconta Vladimiro “e dipinse un quadro, un Cristo in croce dolente. Erano più di 40 anni che non pregava ma in quel caso tornò a farlo, nell’unico linguaggio che sentiva proprio: la pittura”.
Quando Vladimiro uscì dal coma seppe che suo padre – ateo convinto – stava leggendo e dipingendo san Francesco “e io pensai ‘ma è matto?’ e non ero certo l’unico ad essere stupito, maGino si giustificava con gli amici dicendo: ‘scusa ma cosa dovevo fare, pregare Marx? Io ho pregato per mio figlio’”.
Dietro quella prima tela del Cristo in croce, un ex voto che regalò al figlio, Gino scrisse questa dedica: “Mi hai ascoltato Cristo, grazie”.
Poi Covili dipinse un intero ciclo dedicato a san Francesco che fu esposto presso la chiesa di San Damiano ad Assisi. In fondo il poverello di Assisi è il simbolo massimo di quell’antica civiltà appenninica, contadina e cristiana che è parte dell’identità profonda degli italiani. L’identità che rischiamo di perdere.
.
Antonio Socci
.
Da “Libero”, 23 giugno 2019