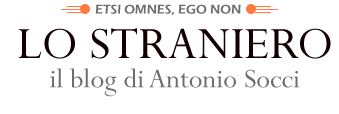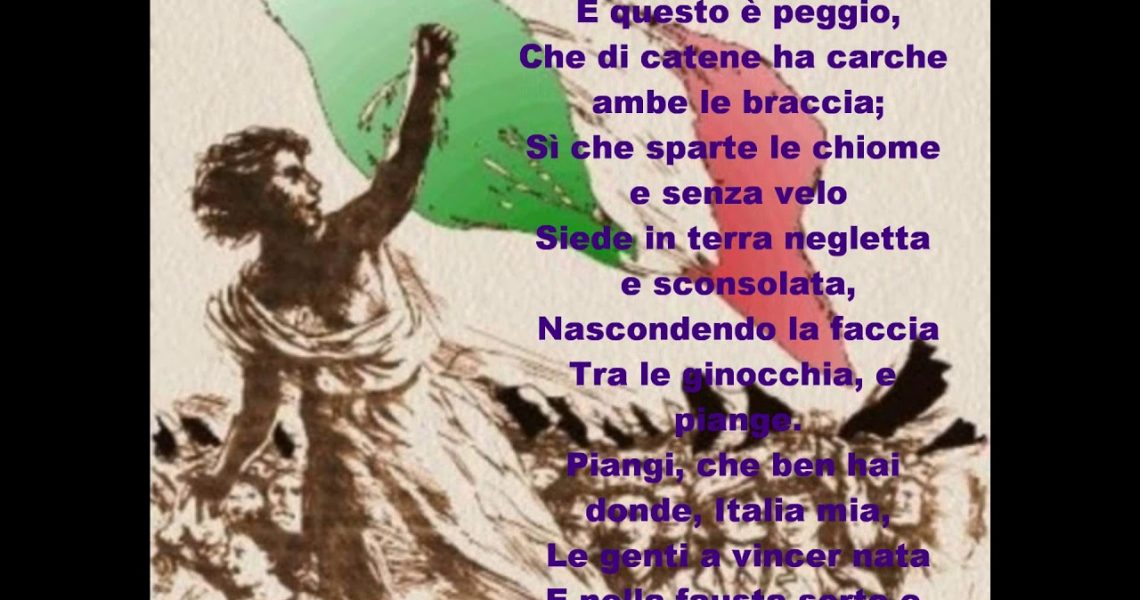A Claudio Magris sono state necessarie ben due pagine del “Corriere della sera” per intimare a quelli di Casapound di lasciar stare il poeta Ezra Pound, perché – sì – aveva orribili idee politiche, ma, afferma il critico triestino, come poeta valeva molto di più. Una colossale e insperata pubblicità per quella formazione politica di destra.
Non entro in questa diatriba. Ma lo strano binomio poesia e politica è molto stimolante e si presta perfino a incursioni ironiche. Sarebbe divertente cercare nella poesia qualche sentenza sull’attualità politica.
Forse si potrebbero applicare al PD o a Forza Italia, per esempio, i più famosi versi di Eugenio Montale: “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato/ l’animo nostro informe (…)/ Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,/ sì qualche storta sillaba e secca come un ramo./ Codesto solo oggi possiamo dirti,/ ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”.
Tuttavia il tema è serio. Ha ragione Magris quando spiega che “non è bene chiedere ai poeti indicazioni politiche”. Perché spesso dicono sciocchezze. E ha ragione pure quando osserva che le “affermazioni ideologiche” dei poeti “sono spesso in contrasto con un loro forte e generoso sentimento della vita e dell’uomo”.
E’ lunga la lista di poeti e intellettuali del Novecento che hanno aderito a partiti e regimi totalitari eppure poetando diventavano altri uomini e spalancavano gli orizzonti infiniti della condizione umana. Perciò è giusto distinguere.
Tuttavia una cosa sono le ideologie, altra cosa sono gli ideali. Una cosa sono le “indicazioni politiche”, altra cosa è l’anima di un popolo, la sua identità nel mondo, cosa che – della politica – dovrebbe essere sempre la bussola spirituale più nobile. Continua