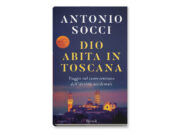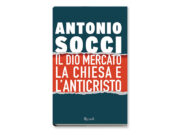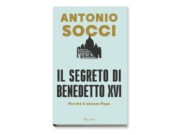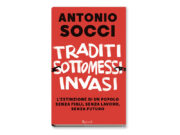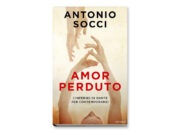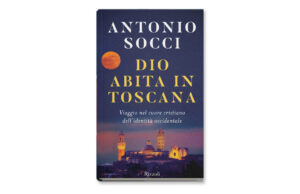Vino e filosofia
Avvenire (21/9) polemizza sul fatto che al Festival della filosofia di Modena Carpi e Sassuolo, fra i vati chiamati a pontificare (e per di più sulla creatività), c’era anche Umberto Galimberti al centro delle note polemiche recenti relative ai suoi libri.
“Pare che a insistere affinché Galimberti fosse invitato” scrive Edoardo Castagna “siano stati gli amministratori locali, non si sa se attratti più dal filosofo-che-va-in-tivvù o più dal filosofo-di-Repubblica; e infatti sul palco si presenta il sindaco di Sassuolo in persona, che di Galimberti esalta gli scritti su Repubblica, ignorando evidentemente che dai fattacci del plagio, o meglio dalla loro scoperta, il filosofo non vi ha più scritto”.
Forse si esagera. Non è che Galimberti debba perdere il diritto di parola per l’incidente in cui è incorso (anche se tarda a darne spiegazioni convincenti). Certo che però il programma di quel festival aveva qualcosa di surreale. Ma a essere surreale è soprattutto l’idea di un festival della filosofia che si svolge a Modena, Carpi e Sassuolo.
Non che l’Emilia debba occuparsi solo di sagre della lasagna. Anni fa è stato fatto un gran bel convegno su Wiligelmo e il romanico emiliano.
Si può spaziare fino all’Antelami. Se si ha sete di cultura si può arrivare a quel fenomeno culturale del Novecento emiliano che è stato Guareschi (o è scomodo da ricordare?).
E magari si potrebbe perfino fare un convegno sulla “parte emiliana” dei libri di Pansa.
Ma se proprio si vuole insistere con la filosofia, suggerirei, per la prossima edizione, almeno una variante localistica.
“La filosofia della piastrella” per le conferenze fatte a Sassuolo.
A Modena e Carpi assegnerei invece questo tema “La filosofia del lambrusco: l’unico rosso che rimane”. Sarebbe un convegno di vino.
Faziosità
Per due volte Vittorio Emiliani, in una sua invettiva sull’Unità (22/9), definisce “mercenari” i soldati che combattevano per difendere stato pontificio, uno dei più antichi stati italiani, dall’aggressione militare dello stato sabaudo.
Il tempo trascorso dovrebbe far ricordare quegli eventi con più equanimità, senza faziosità. E dovrebbe indurre a leggere anche i libri altrui. Consiglierei “La rivoluzione italiana. Come fu fatta l’unità della nazione”, di Patrick Keyes O’Clery.
Questo brillante storico è uno di quelli che Emiliani definisce “mercenari papalini”.
Cattolico irlandese, combatté a Mentana con gli zuavi. Poi, nel 1870, impegnato a cacciar bisonti del Far West, tornò precipitosamente a Roma per difendere il Papa a Porta Pia. Fu parlamentare alla Camera dei Comuni di Londra dove si batté per l’indipendenza dell’Irlanda. Un bel tipo.
Roncalli e Pio IX
Curiosamente Emiliani scrive che il Vaticano II avrebbe dato “direttive sull’abbandono da parte della Chiesa di ogni potere temporale”.
Non si capisce a cosa si riferisca, visto che lo stato pontificio non c’era più da un secolo.
Invece è noto che Giovanni XXIII voleva concludere il Concilio nientemeno con la beatificazione di Pio IX, cioè portando sugli altari proprio il papa di Porta Pia e sempre Giovanni XXIII dichiarò Pio IX addirittura “ispiratore” del Vaticano II.
Inoltre Roncalli, che viene esaltato superficialmente dalla storiografia progressista, celebrando l’anniversario dei Patti Lateranensi nel 1954, parlò del potere temporale dei papi dicendo che “nessuna dinastia d’Europa fu mai meglio fondata in un diritto legittimo e sacro di questa pontificale, che le precedette tutte, le vide nascere e scomparire, e per suo conto non impiegò mai la rapacità, né la violenza con alcuno come instrumentum regni, ma più volte ne fu innocente vittima”.
Fonte: © Libero – 23 settembre 2008