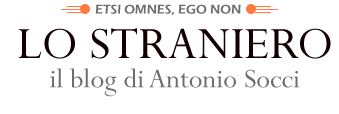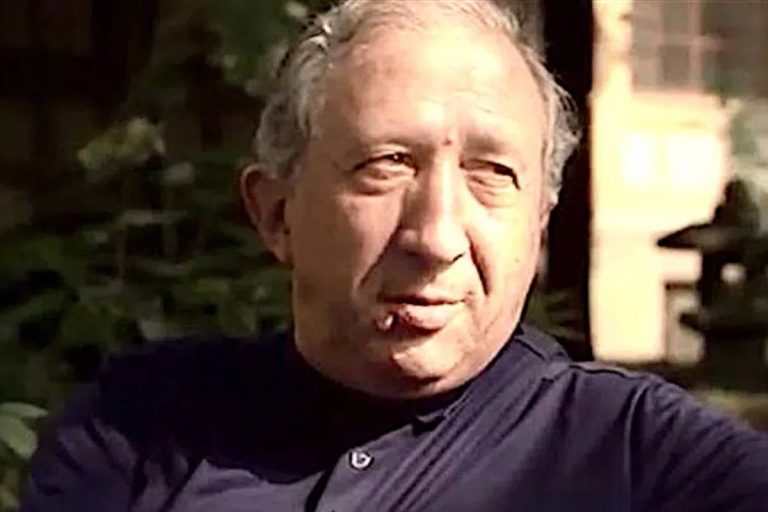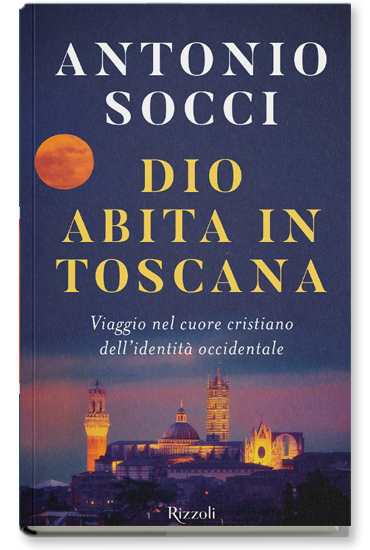22 febbraio 2005/2025. PAPA FRANCESCO: “DON GIUSSANI NON VI PERDONEREBBE MAI SE…”
Venti anni (oggi) dalla morte di don Luigi Giussani. Ne colsero lo straordinario carisma uomini come Augusto Del Noce, Giovanni Testori e Hans Urs von Balthasar, ma in particolare Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger che ne valorizzarono l’opera per la Chiesa (adesso è in corso il processo di beatificazione).
In passato qualche sociologo studiò l’impatto culturale, sociale e politico della sua azione. Ma in questi vent’anni di sonnambulismo conformista, dei media e della cultura, quasi nessuno ha analizzato e compreso l’influenza che egli ha avuto nella storia italiana del secondo Novecento. La Chiesa invece l’ha capita.
Lo dimostra anche un recente scritto del card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: “Il suo carisma e il suo instancabile apostolato” scrive il prelato “non sono solo un dono per la Chiesa, sono anche il contributo che don Giussani ha dato al mondo, perché tutto il mondo è in attesa della Verità, della riconciliazione, della speranza, che possono venire solo da Cristo”.
Don Giussani appartiene ormai a tutta la Chiesa (non a qualche ristretta comunità). La sua “spiccata sensibilità umana, esistenziale, e direi anche filosofica” capace di “cogliere la profondità dell’animo umano” (parole di Farrell) gli hanno permesso di dialogare appassionatamente con la grande letteratura, l’arte e la musica, come sottolineò anche l’allora card. Ratzinger nella messa di esequie.
UN ERRORE INCOMBENTE
Ma sbaglia gravemente chi ritiene che la sua proposta pedagogica faccia leva sul senso religioso (cioè parta dalle grandi domande sul senso della vita dell’animo umano). Proprio Giussani lo negò: “Il cuore della nostra proposta è piuttosto l’annuncio di un avvenimento accaduto, che sorprende gli uomini allo stesso modo in cui, duemila anni fa, l’annuncio degli angeli a Betlemme sorprese dei poveri pastori. Un avvenimento che accade, prima di ogni considerazione sull’uomo religioso o non religioso”.
Fra l’altro liquefarsi in discorsi esistenziali porta i cristiani a non prendere posizione e li rende irrilevanti. Invece Cristo è segno di contraddizione, urta il pensiero dominante, è nel mondo, ma non del mondo.
Il card. Farrell sottolinea: “Don Giussani, con grande enfasi, mise l’accento sull’iniziativa gratuita e sorprendente di Dio che ci è venuto incontro, che si è reso ‘incontrabile’, nella concretezza della vita umana di suo Figlio. Da qui l’insistenza forte sul cristianesimo non come sentimento, come intuizione filosofica di verità sublimi o come rigida esigenza etica, ma come ‘avvenimento’ perennemente presente nella storia grazie alla Chiesa, che è il ‘corpo’ di Cristo, il suo prolungamento visibile nella storia”.
Così Giussani, scrive il prelato, ricorda anche alla Chiesa che non può tacere Cristo o ridurre “il suo annuncio a ‘valori’ o a ‘doveri civili’ o a estrinseche ‘norme morali’, arrivando talvolta a dare quasi l’impressione di ‘vergognarsi’ di Cristo, nella falsa convinzione di non dover ‘imporre’ le sue idee, di non voler risultare ‘dogmatica’”.
IL FUOCO
Il “Gius” era passione ardente per Gesù. Saggiamente Papa Francesco, parlando a chi si ritiene “figlio” di Giussani, ricordò che la sua eredità “non può ridursi a un museo di ricordi. Fedeltà alla tradizione – diceva Mahler – ‘significa tenere vivo il fuoco e non adorare le ceneri’. Don Giussani non vi perdonerebbe mai che perdeste la libertà e vi trasformaste in guide da museo o adoratori di ceneri. Tenete vivo il fuoco”. Questo è il punto dolente.
Antonio Socci
Da “Libero”, 22 febbraio 2025