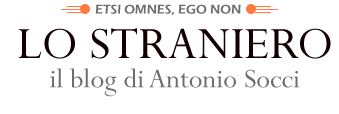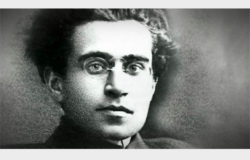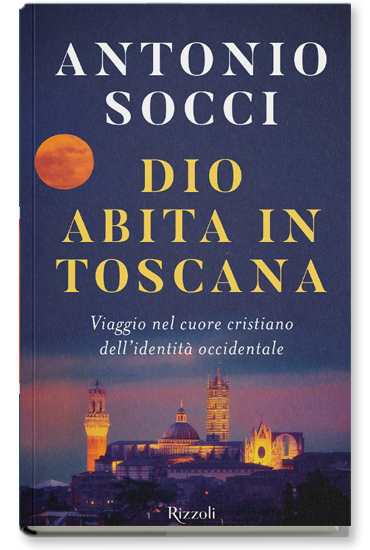L’AUTORE ITALIANO PIU’ TRADOTTO AL MONDO, CANDIDATO AL NOBEL, MA… ANTICOMUNISTA. DUNQUE PERDURA L’OSTRACISMO DI GUARESCHI (CHE ERA CATTOLICO) ANCHE NELLA CULTURA CLERICALE OLTRECHE’ IN QUELLA EGEMONE DI SINISTRA E NEL SISTEMA SCOLASTICO
Giovannino Guareschi è ancora oggi un caso scottante, pure nella cosiddetta “cultura cattolica” (quella ufficiale) che sente lo scrittore emiliano come un corpo estraneo. A causa del suo anticomunismo? Il sospetto viene.
Consideriamo un episodio recente. È uscito un volume di 832 pagine intitolato La preghiera nella letteratura italiana (IPL) dedicato “all’arcivescovo Mario”(Mario Delpini, di Milano). È stato realizzato da più di settanta studiosi sotto la direzione di alcuni docenti dell’Università Cattolica di Milano e del prefetto emerito della Biblioteca Ambrosiana.
Spazia nella letteratura italiana dal XII al XX secolo. Nella parte del Novecentosi presentano autori noti e altri poco noti o quasi sconosciuti. Ma con assenze inspiegabili. La più clamorosa è appunto quella di Guareschi. Viste anche le dimensioni dell’opera, la sua esclusione non si spiega.
I curatori hanno premesso che il volume non ha “alcuna pretesa di sistematicità e di completezza… ci siamo limitati all’analisi di autori particolarmente significativi dal nostro punto di vista”.
E quale sarebbe il loro punto di vista? Guareschi non è “significativo”?Eppure è stato lo scrittore cattolico più importante e più letto dal secondo dopoguerra. Oltretutto le storie di don Camillo ruotano proprio attorno al dialogo con il crocifisso, quindi hanno al centro la preghiera che è il tema del volume di cui parliamo. La sua esclusione perciò è ancora più incomprensibile.
Il card. Giacomo Biffi, nel libro Pinocchio, Peppone, l’Anticristo (Cantagalli), ha scritto: “càpita di scoprire in questi racconti folgorazioni teologiche degne dei più profondi pensatori cristiani”.
E non si tratta solo di uno “scrittore cattolico”. È uno degli autori italiani più tradotti e più letti a livello internazionale. Come si può ignorarlo?
Luigi Mascheroni ha riportato i risultati delle ricerche di alcuni bibliofili sull’opera italiana più tradotta nel mondo: Pinocchio di Carlo Collodi è al primo posto, poi viene il primo romanzo della serie di Don Camillo e infine Il nome della rosa di Umberto Eco.
Però, citando la biografia di Guareschi di Guido Conti, Mascheroni scrive che “è difficile quantificare le edizioni di Don Camillo in lingue particolari (si pensi ai mille dialetti africani o asiatici), eseguite normalmente da missionari in giro per il mondo su permesso a titolo gratuito dello stesso Giovannino. Senza tenere conto di un altro criterio di valutazione per quanto riguarda la popolarità di un autore. Se il libro più tradotto, dalle terre australi all’Islanda, è Pinocchio, l’autore, contando l’opera complessiva, e considerando l’intera saga di Don Camillo, è quasi sicuramente Guareschi”.
Nel 1965 Guareschi fu addirittura candidato al Premio Nobel per la Letteratura, insieme ad Alberto Moravia e a Giuseppe Ungaretti. Eppure, nonostante il suo valore, egli è da sempre ai margini della cultura italiana (e di quella cattolica): è un vero caso letterario e politico.
Qual è lo spazio che viene dato a Guareschi nelle antologie scolastiche o nelle storie della letteratura italiana o nei corsi universitari? Possiamo dire che è zero o vicino allo zero?
Quanti studenti conoscono le sue opere? Perché i suoi libri nelle scuole non vengono fatti leggere come quelli di Vasco Pratolini, Carlo Cassola, Italo Calvino, Alberto Moravia, Elio Vittorini o Cesare Pavese? Chi, fra questi autori, ha avuto il successo internazionale di Guareschi?
Certo, l’inventore di Don Camillo e Peppone era un conservatore ed era molto anticonformista. Deportato dai nazisti in un lager, si rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò. Visse da prigioniero due anni tremendi. Dopo la guerra fondò Il Candido per combattere, con la penna e l’umorismo, le ipocrisie del comunismo contribuendo alla vittoria democristiana del 18 aprile 1948. Ma le cantò poi anche ai democristiani, con cui si scontrò duramente. E ironizzò sui cattoprogressisti (che pullulavano dopo il Concilio Vaticano II), lui che era profondamente cattolico.
Fece anche i suoi errori, ma restò sempre una voce libera e scomoda. Brillante narratore, ironia folgorante, fu estraneo a salotti e cordate ideologiche. Da qui il suo isolamento.
Alessandro Gnocchi e Mario Palmaro in Giovannino Guareschi (Piemme) citano uno dei pochi intellettuali che ne riconosce apertamente il valore, Alessandro Baricco: “Guareschi è un classico. A quindici anni mi piacque più di Salgari, il che era tutto dire… Tutto Guareschi è molto moderno. Da piccole storie elementari, con una sintassi pulita, semplice, Guareschi crea un’epica”.
Quando la cultura italiana metterà fine al suo ostracismo? E il mondo clericale? Guareschi era cattolico ed era un uomo libero: c’è tanto da imparare Le storie di don Camillo, con la loro versione cinematografica, sono ormai molto popolari fra la gente comune, ma mettono in imbarazzo le attuali gerarchie. Perché ricordano un tempo in cui la Chiesa faceva la Chiesa e non andava a rimorchio dei comunisti, anzi li avversava energicamente ed era il più grande punto di riferimento per la nostra gente. Una Chiesa di popolo.
Quella Chiesa ebbe un immenso merito storico, soprattutto alle storiche elezioni del 18 aprile 1948. Un merito che le venne riconosciuto dal padre della cultura laico-liberale, Benedetto Croce. Il quale, ai tanti intellettuali schierati con il Fronte Popolare, che deridevano come bigotto l’elettorato democristiano (fatto di donne devote, contadini e ceti umili influenzati dalla Chiesa), rispose: “Beneditele quelle beghine di cui ridete, perché senza il loro voto e il loro impegno oggi non saremmo liberi”.
Erano stati i parroci come don Camillo a guidare il popolo alla vittoria che ha dato all’Italia libertà e prosperità. Guareschi ha fatto loro uno splendido monumento letterario. La Chiesa di oggi non sa e non vuole onorarli.
Antonio Socci
Da “Libero”,23 ottobre 2025