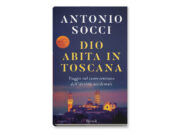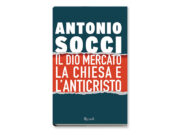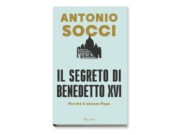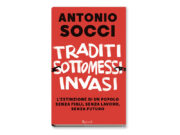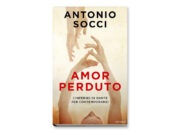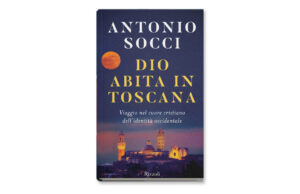Un anno fa sui media italiani si è cominciato a parlare della cantante Taylor Swift che negli Stati Uniti aveva acquisito una straordinaria popolarità. Da noi era dunque famosa per essere famosa (oltreoceano).
In Italia – come è stato notato – nessuno conosceva le sue canzoni(poche le eccezioni). Eppure quando – poco dopo – è stato annunciato il suo tour europeo è iniziata la “febbre” che poi ha portato migliaia di persone allo stadio milanese di San Siro per ascoltarla.
Il caso di Taylor Swift è esemplare e fa capire bene come funziona la macchina del desiderio mimetico, ovvero come si creano i miti (dello spettacolo e non solo) e come si affermano le mode (anche ideologiche).
È una questione che non ha a che fare solo con il costume, con le canzoni o con la politica. Ma con la confezione sociale del prodotto, perché quella attrae la natura stessa dell’uomo.
Per capirlo occorre riferirsi all’opera di René Girard (1923-2015), un pensatore francese che, iniziando dalla critica letteraria, ha elaborato la teoria del desiderio mimetico la quale ha abbracciato poi anche antropologia, sociologia, teologia, psicologia e altre discipline.
Girard – Accademico di Francia – ha insegnato perlopiù negli Stati Uniti ed ha avuto un’influenza tale, in quel Paese, da tornare oggi d’attualità come il pensatore di riferimento del designato vice presidente di Donald Trump, James Vance.
Una premessa generale per capire il suo pensiero. Tutti gli animali hanno dei bisogni che trovano appagamento qui sulla terra. Solo gli uomini fanno eccezione perché, oltre ad avere bisogni, sono abitati da un desiderio infinito che non ha un oggetto naturale (e che resta sempre insoddisfatto) e – siccome fin da neonati essi scoprono e conoscono la realtà attraverso l’imitazione – cercano di individuarlo imitando altri.
“Una volta che i loro bisogni naturali sono soddisfatti” scrive Girard “gli uomini desiderano intensamente ma senza sapere con esattezza che cosa, dato che nessun istinto li guida. Essi non hanno alcun desiderio proprio. Ciò che è proprio del desiderio è di non avere nulla di proprio. Per desiderare veramente, noi dobbiamo ricorrere agli esseri umani che ci circondano, dobbiamo prendere in prestito i loro desideri”.
Il “mediatore” può essere anche l’arte: nella storia dantesca di Paolo e Francesca ad accendere il desiderio è il romanzo cavalleresco di Lancillotto e Ginevra (“galeotto fu il libro”). Lo stesso meccanismo è scatenato dai romanzi cavallereschi letti da Don Chisciotte e da quelli romantici letti da Madame Bovary.
Però può anche esserci la volontà deliberata di suscitare desideri mimetici. La pubblicità funziona così, come macchina dei desideri.
Non pubblicizza un certo prodotto per le sue qualità, ma uno stile di vita o un’atmosfera. Cosicché non si desidera quella bibita, ma la vita di altri che la desiderano: “il desiderio” scrive Marco Dotti spiegando il pensiero di Girard “non esiste in sé. Per esistere ha bisogno dell’esistenza dell’altro. O meglio, di un altro che desidera. […] Un oggetto, uno status, un simbolo, una persona sono dunque appetibili solo se un altro, che io assumo come modello, li desidera prima di me, (…) ecco perché il vero oggetto del desiderio non è mai l’oggetto in sé”.
I nostri miti (ideologici, idolatrici) nascono dal contagio mimetico, ma sempre deludono il nostro desiderio di felicità che è infinito.
Girard aprì la sua prima opera con una frase di Max Scheler: “L’uomo ha o Dio o un idolo”.
Antonio Socci
Da “Libero”, 20 luglio 2024