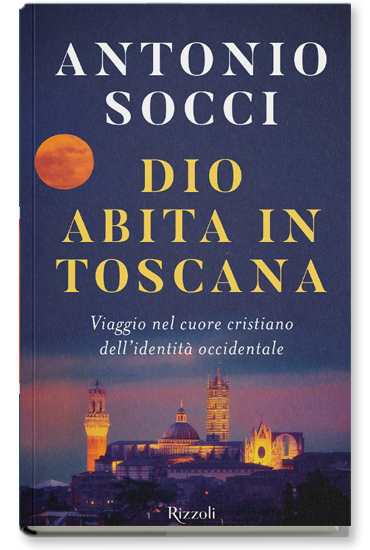“IN TANTI ANNI NESSUNO DEI MIEI MALATI MI HA MAI CHIESTO DI AIUTARLO A MORIRE”. LA TESTIMONIANZA DELLA DOTTORESSA DONATELLA BALDUCCI
Pubblico questa splendida testimonianza della Dottoressa Donatella Balducci perché, oggi che si torna a parlare di legge sul fine vita, è particolarmente illuminante. Ritengo infatti che non ci sia un’emergenza che richieda una legge del genere, ma c’è semmai un’emergenza che chiede la cura dei malati. La legge è una scorciatoia che evita la fatica e la responsabilità della cura. E rischia di essere la classica offerta che poi produce la domanda (una domanda che oggi non c’è se non in casi molto sporadici). Sappiamo bene infatti che le leggi producono una mentalità.
* * *
Sono un’anestesista e rianimatrice dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (AOUS), da poco in pensione e vorrei dare testimonianza di quello che ho vissuto nel mio percorso di medico e di persona che si è trovata quotidianamente ad affrontare malati molto gravi e non sempre guaribili.
La prima osservazione che vorrei fare è che ho visto in questi lunghi anni gli ospedali trasformarsi in luoghi sempre più in grado di diagnosticare e guarire malattie (perché la medicina ha fatto passi da gigante ed è in continua evoluzione ) ma gli ospedali non si sono dimostrati altrettanto adeguati ad accompagnare chi, affetto da una patologia ormai inguaribile, ha bisogno di affrontare il cammino finale della sua vita.
Ancora oggi, troppo spesso sia in ospedale che a domicilio o in altre strutture sanitarie e in generale nella nostra società, si muore male anche per una cultura che ha rimosso la morte come momento inevitabile e necessario della vicenda umana. Nella mia generazione fin da bambini non venivamo allontanati dal defunto che veniva vestito ed esposto in casa, si accompagnava lui e la famiglia con le preghiere, si viveva senza nascondimenti la morte come un evento naturale e così venivamo educati a farci i conti, era una realtà concreta non virtuale come quella che vivono oggi per lo più i bambini e i ragazzi.
Per altro il cammino finale della vita non sarà necessariamente breve perché parliamo non solo di malati affetti da tumori ma anche di malattie neurologiche progressive e di tutte quelle patologie dove il paziente non può essere guarito, ma ha una grande necessità di avere terapie per il dolore, di essere aiutato ad affrontare l’ansia e la depressione, la perdita della capacità cognitiva, dell’autonomia, della possibilità di muoversi, di gestire gli esiti delle chemio e radioterapie, il pensiero del distacco dai familiari, la preoccupazione per lo sconvolgimento della vita di tutta la famiglia, insomma un complesso e variegato corteo di sintomi e necessità : non a caso non si parla di solo dolore ma di “SOFFERENZA TOTALE”.
Da qui è chiaro che, se non si può guarire, si può e si deve CURARE. Paradossalmente i medici, sempre più specializzati ad affrontare il particolare, non sono così preparati ad un APPROCCIO GLOBALE del paziente nella sua unità della persona e meno che meno ad accompagnarla a morire, né il corso universitario educa a questo gli studenti di medicina.
E dire che i nostri ospedali come il Santa Maria della Scala di Siena erano nati come “OSPITALI” cioè luoghi di accoglienza dei bisogni più vari delle persone. Ospiti denutriti, agonizzanti, piagati, febbricitanti, venivano accolti e accuditi come persone di riguardo e trattati con profondo rispetto e sacralità. Da questa sollecitudine, carità e creatività, che derivava da una cultura cristiana, sono nate tutte le attività assistenziali ( ospedali, lebbrosari, asili ecc. ).
Cicely Saunders che è considerata la fondatrice delle CURE PALLIATIVE(da “pallium “il mantello di San Martino ), prima infermiera e poi medico, mutuò proprio da questa tradizione assistenziale della Chiesa il concetto di Ospitale, “ Hospice” in inglese, dove il soggetto delle cure sono gli incurabili, i moribondi, gli anziani, i malati cronici: gli “ultimi”, quelli che ora chiamiamo i “malati terminali” cioè quelli con una prognosi infausta, ma non necessariamente con una vita brevissima e il tempo rimasto da passare è un tempo con la propria famiglia o comunque con le persone che aiutino il malato a trascorrere il più serenamente possibile il prezioso tempo che gli resta.
Il modo e i luoghi per rispondere a questo bisogno di accudimento totale oggi sono declinati nelle Cure Palliative (domiciliari, Hospice, RSA, ospedale ).
La MIA ESPERIENZA con tanti malati in queste condizioni è che laddove il paziente e la sua famiglia sono accompagnati, accuditi, curati fino alla fine e addirittura anche nel lutto, come prevedono le cure palliative, NESSUNO dei malati che io ho incontrato nei quattro anni iniziali di Dottorato sulle Terapie del Dolore e poi da rianimatrice in ambiente ospedaliero, mi ha chiesto di aiutarlo a morire o ha espresso il desiderio che gli praticassi l’EUTANASIA.
Mi sono chiesta qual è allora la discriminante per cui maturare una posizione di voler essere aiutati a suicidarsi?
La sofferenza è certamente per tutti un grande interrogativo sul senso stesso della vita e quindi anche della morte che ne fa ineluttabilmente parte e non ci sono risposte automatiche sul perché ci sia. Nessuno, neanche con la fede, ha una risposta sul perché esistano sofferenze, alcune particolarmente stridenti e intollerabili come, ad esempio, quelle dei bambini (infatti io spesso dico al Creatore che a volte è troppo Creativo e prima o poi qualcosa ce la dovrà spiegare … ).
Eppure io ho visto vivere il dolore e la morte con un senso, addirittura con letizia e pace. Ho visto nascere situazioni di assoluto stravolgimento della propria vita personale e familiare a causa di una grave malattia, che sono diventate occasioni di cambiamento, di riconciliazioni, di intensità e verità di momenti più significativi che tutto il resto della vita passata, imprevisti e inimmaginabili.
E mi sono detta forse, anzi certamente, il senso e il valore della vita è più grande di quello a cui noi siamo legati: una vita efficiente, produttiva, perfetta che si potrebbe riassumere con un ”SI E’ SE SI FA” e la felicità come assenza di problemi o contrarietà dai nostri schemi.
In questo nessuno come i bambini, i piccoli pazienti, mi ha insegnato che IO NON SONO LA MIA MALATTIA, la malattia non è l’ultima parola su di me. Ho nel cuore bambini con gravissime patologie che riuscivano a farsi coinvolgere in una storia, a mimare canzoncine insieme, ad ascoltare e ridere di una storiella buffa. Una bimba napoletana prima che l’addormentassi per fare la RM mi raccontava barzellette e le mancava poco tempo prima di salire in Cielo.
Così come ho imparato dalle loro madri, ma anche padri, cosa vuol dire accogliere, sostenere, dare tutto se stessi senza chiedere nulla in cambio, sperare contro ogni speranza valorizzando ogni piccolo passo.
Ovviamente la croce, la fatica e i momenti di sconforto ci sono, ma laddove viene creato un ambiente accogliente e che si fa carico di seguire non solo gli aspetti strettamente sanitari ma sostenendo anche umanamente, psicologicamente, dando le ragioni di ogni passo e decisione terapeutica, spendendo tempo per ascoltare, si crea un’ALLEANZA TERAPEUTICA tra medici, personale sanitario, pazienti e loro familiari, che è l’arma principale sia per la cura che per accompagnare alla fine quando non si può più guarire.
Io sono convinta per la mia esperienza che il medico non deve essere distaccato, per una falsa idea che si prendono meglio le decisioni, perché l’empatia (che è il patire con il malato) genera fiducia, combatte la piaga della medicina difensiva e al contrario sviluppa la creatività e la capacità di trovare le migliori soluzioni e di inventarne anche di nuove, perché là dove ti sta a cuore e partecipi con tutta te stessa alla situazione del tuo paziente, sei ancora più attenta ai segni e sintomi.
Non a caso la Cicely Saunders è stata la ispiratrice di un concetto cardine della attuale terapia del dolore che è la somministrazione degli analgesici ad intervalli regolari e non al bisogno quando il dolore è al massimo, con un concetto di prevenzione dello stesso, cui corrisponde maggior benessere per il paziente e minor consumo di oppiacei. Applicando questa tecnica, cui oggi se ne sono aggiunte sempre di più efficaci, si può confermare quanto già la Cicely ebbe a constatare e cioè che è possibile alleviare le sofferenze del 90% dei pazienti o ridurle al minimo laddove non si possono eliminare completamente e che il dolore e la sofferenza sono intollerabili soltanto quando non si ha intorno qualcuno che si prende cura di noi e, io aggiungo, sempre partendo dalla mia esperienza, che abbia una CONVINZIONE UMILE.
Umile perché non intende fare violenza imponendo qualche cosa ma occorre una convinzione che possa arrivare dove le medicine non riescono fino in fondo a colmare tutto il bisogno più grande e ultimo e, che nel pieno rispetto della libertà della persona, le stiano accanto aiutandola a vivere con pienezza anche l’esperienza unica e irripetibile della morte. La mia convinzione, ma non pretende essere quella di tutti, nasce dall’ incontro con Cristo e la sua Chiesa ed è la fede che ci rende tutti fratelli e nel malato vedo quel volto di Cristo in Croce da servire con amore, davanti al quale inginocchiarsi, quel Cristo che è morto e risorto per noi e perciò capisco quando Cicely Saunders disse a un monaco del Santo Sepolcro dove si era recata in visita : “ Lavoro con i morenti e vedo continuamente la risurrezione”.
Quindi curare è un VENERARE la vita in coloro che sono in condizioni di doverla perdere e questa posizione, ho potuto constatare, genera anche in chi non condivide questo credo, una speciale comunione dentro cui è più facile che il paziente sia se stesso, esprima le sue paure, sia libero da quel circuito di “non verità” per cui fa finta di non sapere che morirà e i parenti fingono con lui che non sia così ma ciò che salva dalla disperazione è una cura e una compagnia al destino ultimo.
Questo non vuol dire che al posto di curare si parla col malato della fede o di Gesù perché come diceva il cardiochirurgo Giancarlo Rastelli, Servo di Dio e in corso di beatificazione: “la prima carità che il malato deve avere dal medico è la carità della scienza” altrimenti si fa del paternalismo o del pietismo e quindi occorre studiare e aggiornarsi per offrire la migliore medicina ma anche “sapere senza amore è nulla, è meno di nulla”, così come “credeva fermamente che gli ammalati fossero ‘ammalati da vivere’ non da morire e che in ogni modo vada salvata la loro dignità di persone totali, integrali”.
Ai suoi studenti quando insegnava come affrontare la visita al malato diceva di “incontrarlo come fratello di un comune destino, non come un numero o come un carcerato dell’ospedale… Incontralo in Cristo… L’ammalato è l’altro da servire fino all’ultimo”.
Tra l’altro questo è il contrario dell’Accanimento Terapeutico (cioè la persistenza di terapie che sono considerate inutili, sproporzionate o dannose rispetto all’obiettivo di migliorare la salute del paziente e che possono anche aggravare la situazione o prolungare solo la sofferenza), accanimento terapeutico che è figlio di una medicina che non riconosce la sconfitta e il limite o peggio si trincera dietro un difensivismo che guarda a se stesso e ai pericoli connessi con il fatto che un malato muoia nelle tue mani.
Prima ho detto che non ho mai conosciuto un paziente che, se non lasciato solo o con scarse cure per affrontare il cammino verso la morte, mi abbia chiesto di aiutarlo a farla finita, ma tutt’oggi assistiamo alla insufficienza della possibilità di accedere alle Cure Palliative anche se la situazione sta migliorando rispetto al 1989 quando, insieme alla Dottoressa Giuliana Ruggieri, un’amica chirurga, volevamo costituire un gruppo e in parte su base volontaristica lo abbiamo fatto, di assistenza domiciliare per le cure palliative, ma la Direzione Sanitaria non accolse di fatto il progetto che per altro era vantaggioso anche da un punto di vista economico oltre che innovativo.
Credo che anche da questa sfiducia, per aver fatto esperienza di mancanza di cure adeguate, sia maturata l’idea che possa essere meglio interrompere la vita che affrontare un percorso di sofferenza con l’incognita di non essere seguiti adeguatamente.
Io credo che soprattutto sia una richiesta figlia di una mentalità sempre più dominante per cui io sono in quanto mi AUTODETERMINO e ciò sembra coincidere con la libertà, ma il punto è se questo coincida anche con la felicità.
Qualcuno ci ha voluti e amati, se no a che serve tutta questa bellezza da cui siamo circondati (“a che tante facelle?” chiedeva Leopardi), perché amiamo i nostri cari, i nostri amici e sentiamo che anche lo sconosciuto che incontriamo in autobus ci appartiene? Perché abbiamo in comune lo stesso destino.
Allora possiamo accettare che uno decida di porre fine alla sua vita e l’aiutarlo in questo farlo passare come un atto di carità, di rispetto della sua libertà e unico mezzo per porre fine alla sua sofferenza?
Cionondimeno il suo grido di dolore ci deve scuotere, ci deve far lottare con tutte le nostre forze e capacità per offrire una strada più umana, solidarietà, ascolto, compagnia.
Vuol dire non rispettare la sua volontà? Ma siamo sicuri che la volontà di chi vuole il suicidio assistito non sia inficiata da perdita di speranza, da depressione, da solitudine, da mancanza di una proposta che dia senso alla vita?
Immaginiamo che un nostro caro, un figlio, un genitore ci comunichi questa decisione: chi potrebbe stare a guardare senza interrogarsi sulla propria responsabilità e non senza proporgli un accudimento che vorremmo condividere con lui?
Non imporre, certo, ma in ogni caso io ho scelto di essere medico per mettermi al servizio e in difesa della vita dal suo concepimento fino alla fine: PRO VITA CONTRA DOLOREM SEMPER diceva un mio maestro e non potrò mai accettare di stare a guardare mentre un paziente pigia un bottone che aziona la pompa preparata con la dose letale del farmaco e stare a controllare che ciò avvenga senza intoppi.
Difendere e servire la vita non è una ideologia perché la vita è il dono più grande che abbiamo e quindi è un imperativo anche quando diventa fragile. Viceversa la conseguenza inevitabile sarà avviarci verso una “CULTURA DELLO SCARTO “(che Papa Francesco definiva “uno dei fenomeni più drammatici del nostro tempo“), dove in situazioni di malattia grave e terminale il malato o la persona fragile si sentiranno in dovere, avendo una legge che promuove il suicidio assistito, di liberare la propria famiglia da un peso e il passo verso l’EUTANASIA è assicurato.
Io però ho fiducia che tanti medici, operatori sanitari, persone comuni, vogliano lottare perché le Cure Palliative siano garantite a chiunque ne abbia bisogno e soprattutto per promuovere una CULTURA DELL’ACCOGLIENZA dei più fragili e del rispetto della sacralità e inviolabilità della vita.
Donatella Balducci