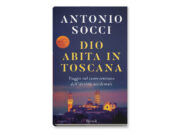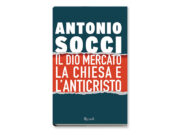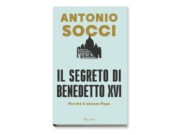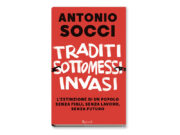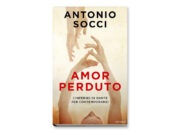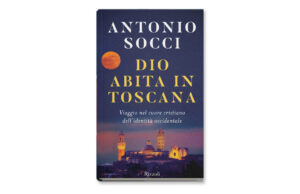VIRGOLETTE
Pietro Citati aveva lanciato un appello sulla Repubblica (7/4): “Non uccidete l’eleganza del punto e virgola”. Una dotta polemica. Peccato che poi abbia fatto più scalpore quella sulle virgolette, lanciata da altri.
Il povero Umberto Galimberti – anche lui grande firma di Repubblica – ha passato una settimana d’inferno perché vari giornali hanno rilevato “le accidentali somiglianze tra alcuni passi dei suoi libri e quelli di Giulia Sissa, Salvatore Natoli e Alida Cresti” (Il Sole 24 ore, 27/4).
Ma sono davvero così importanti le virgolette? Sergio Givone, che insegna Filosofia a Firenze e anche lui scrive per Repubblica, ha spiegato al Giornale (25/4): “La filosofia è confronto di idee e quelle idee che riconosco come giuste diventano mie…
Questo non toglie che le fonti siano fonti e vanno citate…Però ho l’impressione che in questo caso si rischi di fare una demonizzazione inutile…
Per giustificare in parte Galimberti va detto che è un filosofo che si confronta con le idee degli altri. L’Italia è piena di filosofi sprezzanti verso le idee altrui, lui invece è ricettivo… Il problema nel nostro Paese è la separazione tra la storia della filosofia e la ricerca speculativa, non le virgolette…”. Insomma: il problema è “ben altro”, come sempre, e viva Galimberti “il ricettivo”.
PLATONE
Sempre Galimberti tiene una rubrica sul magazine femminile della Repubblica. Non si sa se quella del 26 aprile sia stata scritta prima che scoppiasse la tempesta. Ma fa molto riflettere fin dal titolo: “Nell’amicizia la scoperta di sé”.
Il Nostro scrive: “Tuteliamo l’amicizia. Forse è l’unico spazio che ci rimane per un residuo di sincerità, una sorta di riunificazione con noi stessi dalla dissociazione che ci è imposta, una forma di autoriconoscimento secondo quel modulo che Platone ci indica là dove dice: ‘Se uno con la parte migliore del suo occhio guarda la parte migliore dell’occhio dell’amico, vede se stesso’ ”.
In effetti chi, leggendo Galimberti, avesse la sensazione di leggere se stesso dovrebbe ritenerlo un segno di profonda amicizia. Platonica. E senza virgolette.
ANNIVERSARI
La cosiddetta “Battaglia di Valle Giulia”, a Roma, è uno dei simboli del ’68.
C’erano tutti, da Oreste Scalzone a Marco Bellocchio, da Massimiliano Fuksas (quello che da Santoro impartisce memorabili lezioni di storia romana) a Franco Piperno, da Paolo Liguori a Renato Nicolini, con la partecipazione speciale del giovane Giuliano Ferrara.
Paolo Pietrangeli dedicò una canzone al mitico evento.
Invece Pier Paolo Pasolini allora scrisse che non sino. Infatti Marco Pannella ha dichiarato, come riporta il Corriere della sera (25/2): “Che aspetta Walter a candidare Riccardi di Sant’Egidio o Enzo Bianchi, o monsignor Paglia? Ho un lungo elenco di veri credenti, da invitare nel Pd”. Questi “veri credenti” somigliano ai “sinceri democratici” e ai “veri antifascisti” a cui veniva rilasciata apposita patente dal Pci. Su Repubblica (25/2) poi si riporta un’altra sorprendente rivendicazione di Pannella: “Noi siamo stati i primi a candidare una suora”. E questi sarebbero i laici… La Dc mai l’avrebbe fatto.
IL CANTO DEI GALLI
A proposito di scudocrociato, va segnalata la vigorosa sferzata di Ernesto Galli Della Loggia, sul Corriere (24/2), contro la Dc e i “politici cattolici”. In coda fa un’apologia di “uomini, ambienti e iniziative”, specialmente “non credenti” (o credenti estranei al partito cattolico e alle organizzazioni cattoliche) che loro sì hanno il merito (tutto loro! solo loro!) di aver messo a tema, negli ultimi anni, l’identità cristiana nella cultura occidentale: “sono stati loro, i loro libri, i giornali da loro creati o diretti, le loro iniziative, che hanno riportato con forza all’attenzione dell’opinione pubblica e della cultura laica il grande tema delle radici cristiane, dell’ ‘identità cristiana’… senza che alcun politico cattolico c’entrasse nulla”.
Galli ha ragione, ma verrebbe da dire – con Pigi Battista – fuori i nomi. Bisognerebbe trarli dal semi-anonimato dei loro salotti iniziatici per ringraziarli. E magari per chiedere loro una riflessione su questa domanda: quanti dei sei milioni di pellegrini che ogni anno si recano a San Giovanni Rotondo o altrettanto numerosi a Lourdes e Medjugorje, mostrerebbero di conoscere quegli intellettuali benemeriti? Quasi nessuno. Eppure la fede cristiana di quei milioni è nata e si è rinvigorita nonostante una così grave lacuna. Anzi si comunica a molti altri. Come si spiega?
Fonte: © Libero – 26 febbraio 2008