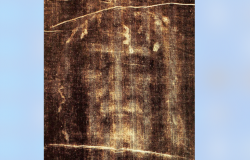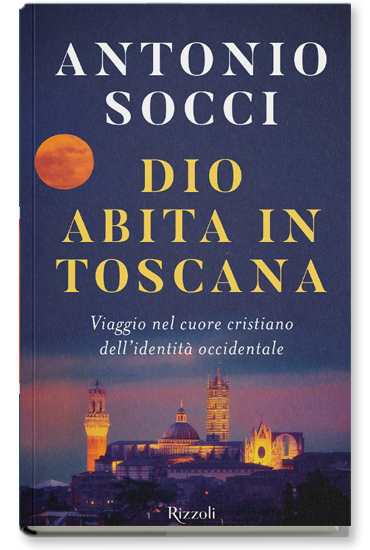GRILLO, GENTILONI, IL NICHILISMO… E MIO PADRE
Beppe Grillo per gli auguri natalizi ha rilanciato un vecchio articolo di Goffredo Parise del 1974, intitolato “Il rimedio è la povertà”, ed è stato rimbeccato da Giuseppe De Rita che ha notato come “i cantori della povertà non sono mai poveri”.
In effetti le cronache mondane di Dagospia non ci mostrano un Grillo col saio che mangia pane secco, ma un paffuto signore nella villa sul mare o sullo yacht ancorato in Costa Smeralda.
Buon per lui, ma non sembra il miglior testimonial dell’idea di “decrescita felice” di Serge Latouche, anche perché la decrescita l’abbiamo avuta davvero in questi anni e gli italiani hanno verificato che non è per nulla felice.
E’ anche una gaffe politica quella di Grillo, considerato che il M5S oggi fa il pieno di consensi proprio fra i giovani e gli arrabbiati che sono rimasti vittime del crollo del Pil in questi anni di crisi. Del resto questo pontificare di povertà dallo yacht fa tornare in mente un tornante grottesco della storia italiana: gli anni Settanta.
Li ricordo bene. Quando, a 14 anni, arrivai al liceo, io – che ero figlio di un minatore e venivo dalla campagna (dove non c’era nemmeno l’acqua corrente nelle case) – mi trovai davanti a uno spettacolo sorprendente.
I figli dei notai e dei primari, degli industriali e dei commercianti miliardari, vestivano di stracci e parlavano a nome del proletariato, sbandierando dappertutto “la falce e il martello” senza aver mai preso in mano – per lavorare – nemmeno un cacciavite.
MIO PADRE
Mio padre detestava tali figli di papà e mi diceva: “questi distruggono la scuola che per i poveri è l’unica possibilità di farsi un futuro, perché loro poi hanno i babbi facoltosi che li mandano a studiare all’estero o garantiscono comunque un futuro”.
Aveva ragione. Lui lo diceva con l’orgoglio e la rabbia del militante democristiano che da ragazzo avrebbe voluto studiare, ma che non poté permetterselo (anche mio nonno infatti era minatore): mio padre dovette andare a lavorare a 9 anni come garzone ed entrò in miniera a 14, nel 1939.
Non si è mai permesso una vacanza al mare o in montagna, ma con i pochi soldi risparmiati comprava libri (aveva letto “Buio a mezzogiorno” di Arthur Koestler quando la ricca intellighentsia italica ancora venerava Stalin).
Amava l’opera lirica e aveva acquistato a buon prezzo tutti i 33 giri con le opere di Puccini, Verdi e Donizetti. Spendeva gli altri spiccioli in colori a olio e tele perché dipingeva e ancora ho un suo quadro che rappresenta una tragedia in miniera (dove lui stesso, nel febbraio 1953, ha rischiato di morire dissanguato).
Per secoli i figli dei contadini erano stati costretti a fare i contadini, i figli dei minatori facevano i minatori e i figli dei medici e degli avvocati – chissà perché – avevano una tale intelligenza “superiore” che li portava fatalmente a fare i medici e gli avvocati.
Dagli anni Sessanta non fu più così. E mio padre era orgoglioso perché grazie al suo partito, la Dc, per la prima volta nella storia italiana, tutti i figli del popolo potevano studiare gratuitamente (è stata l’unica vera rivoluzione italiana e tutta pacifica).
Per lui era un sogno che i suoi figli potessero laurearsi. Così detestava i figli di papà che – con la prepotenza dei “rivoluzionari” da salotto – sbaraccavano la scuola di noi poveri.
FORMIDABILI QUEI DANNI
Molti di loro – dismessi gli abiti rivoluzionari – hanno poi fatto brillanti carriere borghesi. Sempre però continuando a stare “à gauche”, com’è d’obbligo nei salotti, sul (ca)viale del tramonto del marxismo.
Oggi è arrivato a capo del governo proprio un rappresentante di quella generazione sessantottina. Sia chiaro, Paolo Gentiloni è una persona di rara gentilezza e serietà, ma la sua biografia è obiettivamente emblematica di un’epoca storica.
Infatti questo discendente dei conti Gentiloni Silveri, nobili di Filottrano, Cingoli e Macerata (con avi famosi a Roma), ha iniziato la sua attività politica con le occupazioni di un famoso liceo della capitale, il Tasso, nel 1970.
Entrò nel “Movimento studentesco” di Mario Capanna e poi – a scelta fra “Democrazia proletaria” e il “Movimento lavoratori per il socialismo” – scelse il secondo, che era un gruppo maoista, diventando segretario regionale del Lazio, fino all’unificazione col “Partito di unità proletaria per il comunismo”.
Tutte queste sigle che sbandieravano “proletariato”, “comunismo” e “lavoratori” erano piene di figli di papà come il conte Gentiloni che almeno – e va a suo onore – aveva anche allora un carattere mite e riflessivo, assai raro fra i suoi compagni arroganti e violenti.
E’ però il simbolo di una generazione di figli di papà che si è baloccata con l’ideologia della povertà (altrui) e della rivoluzione, facendo un gran casino nella scuola e nella società, e che – peraltro – è uscita dall’ideologia non per proprio merito, ma per il fallimento del comunismo.
E ne è uscita senza cocenti autocritiche, perlopiù spalancandosi luminose carriere nel giornalismo, nella finanza, nell’università, nell’industria e nella politica.
Dove tuttora alcuni di quei signori continuano a dettar legge, ritenendosi gli “illuminati”, e definiscono il “pensiero corretto”: se non ti allinei al mainstream sei sempre considerato un buzzurro reazionario (negli anni Settanta ti fulminavano dandoti del “fascista”).
IL PIL E KENNEDY
Anche il tema della “decrescita”, ennesimo sproloquio da salotto sulla povertà, è spuntato a sinistra (ambito ecologista rossoverde) ed è passato nei circoli grillini.
De Rita però ha dato a Grillo una risposta assurda: “questo Paese ha formato la sua identità sulla crescita, la decrescita significherebbe perdita di identità”.
Ma che dice? Una civiltà che ha 2500 anni di storia avrebbe nella crescita del Pil la sua identità? In realtà lo stesso concetto di “Prodotto interno lordo” andrebbe totalmente rivisto.
Fu Robert Kennedy in un celebre discorso tenuto il 18 marzo 1968 – tre mesi prima di essere ammazzato – a demolire l’idea di misurare un Paese con il Pil, che di per sé cresce pure col terremoto o costruendo bombe atomiche: “Il Pil” disse Kennedy “non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei valori famigliari o l’intelligenza del nostro dibattere. Il Pil non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in poche parole, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”.
Insomma la crescita del Pil non significa crescita della felicità. Del resto nemmeno la sua decrescita fa diventare felici: “i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria”.
POVERI, MA BELLI
Quello che forse Grillo voleva dire è che c’è stato un tempo in cui il nostro popolo era più povero, ma aveva più gusto della vita, era più umano.
Ha torto De Rita a dire che “i poveri non cantano”. E aveva ragione Pasolini ricordando con nostalgia un popolo contadino e cattolico che cantava e sorrideva alla vita.
Del resto anche oggi le cronache ci parlano di miliardari infelici che muoiono da disperati e di persone che vivono modestamente (e perfino nella malattia), ma si sentono felici.
La felicità dunque non dipende dalla crescita o dalla decrescita del Pil, ma dal senso che si dà vita, dalla forza morale, dalla spiritualità che si vive.
Ecco cosa sfugge a Grillo: se oggi siamo meno felici di quando eravamo più poveri è perché la valanga del nichilismo, negli ultimi 50 anni, ha fatto il deserto.
E’ “la dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie” (Benedetto XVI).
E’ questo il disastro (prodotto dalle ideologie). Ed è ciò che non si vuol vedere.
Antonio Socci
Da “Libero”, 29 dicembre 2016
.
Facebook: “Antonio Socci pagina ufficiale”
Twitter: @AntonioSocci1