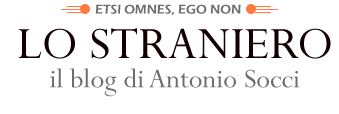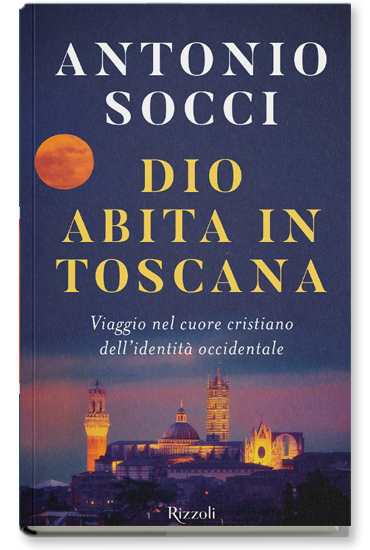LA SOCIETA’ “LIQUIDA” DELLA SOLITUDINE E DELL’INCERTEZZA DESCRITTA DA BAUMAN E LA “DITTATURA DEL RELATIVISMO” DI RATZINGER
Attraverso il pensiero di Zygmunt Bauman, nel centenario della nascita (1925-2017), si coglie la mutazione epocale che viviamo.
Attorno agli anni Sessanta del ‘900, Bauman, formatosi in Polonia e inizialmente marxista (anche se critico), vede la modernità caratterizzata da strutture pesanti, burocratiche, da progetti di ingegneria sociale, da un forte controllo statale.
Bauman, ebreo polacco che conobbe prima l’orrore del nazismo, poi quello del comunismo, mostra quale poteva essere ed è stata la perversione totalitaria di questa modernità.
Alla cui “solidità” succede, con il crollo del Muro di Berlino e l’irrompere della globalizzazione, una trasformazione planetaria e Bauman coglie nella “liquidità” il connotato della nuova èra.
È ormai diventato un luogo comune. La categoria della “liquidità” permette di racchiudere tutto il presente in uno slogan banale e apparentemente evidente.
Del resto molti titoli dei libri di Bauman sono eloquenti: Modernità liquida, Amore liquido, Vita liquida, Paura liquida, Arte, liquido?, Culture in a Liquid Modern World, Liquid surveillance, Communitas. Uguali e diversi nella società liquida, Futuro liquido.
È vero che ogni grande pensatore ha un’idea e attorno ad essa articola tutta la sua riflessione. Ma la sua non è affatto un’idea semplicistica come potrebbe sembrare. Anzi è geniale.
Del resto la “liquidità” è una parola che evoca il “liquidare” e soprattutto il “liquido” cioè il denaro, la finanza, che è il potere reale che, con la globalizzazione, ha conquistato il dominio anche sottomettendo gli stati e la loro sovranità.
La “liquidità” rappresenta pure la voluta e conseguente liquefazione di tutte le identità, da quelle collettive, nazionali, religiose, popolari, a quelle individuali, familiari e sessuali. Come pure la dissoluzione dei rapporti sociali e lavorativi. È l’età dell’incertezza, della paura, della solitudine, del disagio, dell’io senza appartenenze, diventato un fascio di istinti.
La serie dei suoi libri che ho citato rappresenta il tentativo di Bauman di declinare in tutti gli aspetti – da quelli individuali più intimi a quelli collettivi, su scala planetaria – il dominio della liquidità. Come ha fatto nei suoi interventi sui media.
Ne darò solo un esempio relativo ai sentimenti e al lavoro:
“Il mercato” dice Bauman “ha fiutato nel nostro bisogno disperato di amore l’opportunità di enormi profitti. E ci alletta con la promessa di poter avere tutto senza fatica: soddisfazione senza lavoro, guadagno senza sacrificio, risultati senza sforzo, conoscenza senza un processo di apprendimento. L’amore richiede tempo ed energia. Ma oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare l’altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma possiamo comprare tutto, non l’amore”.
Su questo “tutto e subito” Bauman spiega: “Il ‘68 potrebbe essere stato un punto d’inizio, ma la nostra dedizione alla gratificazione istantanea e senza legami è il prodotto del mercato, che ha saputo capitalizzare la nostra attitudine a vivere il presente”.
Il ’68 come strumento del mercato che diceva di combattere: idea che ricorda Pasolini e Giussani. Ratzinger mostrò la conclusione di quella storia: “una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”.
Antonio Socci
Da “Libero”, 22 novembre 2025