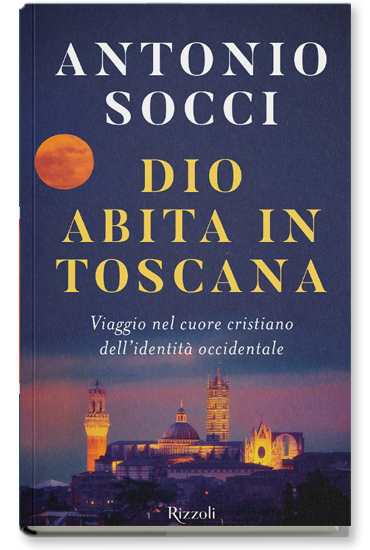METAFISICA DEL TURISMO
Il ponte del 2 giugno, malgrado le nuvole, ripropone il boom turistico che, per le città italiane, sarà, nelle prossime settimane, un’allegra e variopinta invasione.
Il fenomeno ha un lato (molto) positivo perché porta ricchezza, soprattutto se si tratta di turisti stranieri, ma ha anche un aspetto che scatena polemiche: è la cosiddetta “turisticizzazione” che pare sia responsabile della fuga degli abitanti dai centri storici e dell’aumento dei costi. Ultimamente si è aggiunto lo scontro sulla moltiplicazione dei B&B e sui portali internet per gli “affitti brevi”. La discussione ferve su questi aspetti prosaici.
Nessuno discute del merito e di come si può superare un turismo mordi-e-fuggi, che si esaurisce nel selfie al Ponte di Rialto o nella Piazza dei Miracoli o alla Fontana di Trevi o in Piazza San Marco o al Colosseo o in Piazza del Campo o davanti al David di Piazza della Signoria.
Bisognerebbe chiedersi cos’è che attrae e affascina così tanto della Grande Bellezza italiana e perché si scivola velocemente su di essa che invece potrebbe e dovrebbe essere gustata con più tempo, intensità e consapevolezza, da un turismo di qualità.
“Purtroppo” scriveva Philippe Sollers “la ‘sociomania’ ha causato una violenta espulsione dalla Storia della Cultura (…). Questo fenomeno ha conseguenze anche sulla percezione dell’arte: che viene vista senza essere guardata, intesa senza essere ascoltata, sfiorata senza essere toccata”.
Ma chi e dove e come educa il gusto e dà gli strumenti per capire le meraviglie di cui l’Italia è piena? Più dei libri frequentiamo i social. Anche la scuola non suscita passione, ma distacco e noia.
“Siamo dentro un mondo virtuale, totalmente estetico o estetistico, caratterizzato dall’eccitazione da un lato e dall’oblio dall’altro. Il postmoderno” scrive Massimo Borghesi “è la estetizzazione del mondo, ovvero è la società, il mondo ridotto a spettacolo”.
In effetti città come Firenze, Venezia, Roma e altri centri italiani, possono sembrare alla distratta folla dei turisti un immenso emporio delle meraviglie, il più grande deposito da rigattiere a cielo aperto del globo, pronto a fornire materiale per selfie e banali spot pubblicitari.
Dunque un magazzino certamente pieno di capolavori, ma su cui incombono l’effetto luna park e l’effetto Pompei, la “città morta”. Eppure c’è vita in tutta questa grande bellezza e tanta gente lì cerca qualcosa. Ma cosa?
Spesso gli intellettuali e gli snob ironizzano sulle folle di turisti inconsapevoli che, avvolti da odori di sudore e di pizzeria, si aggirano nelle città d’arte con cappellino e borraccia. Li rappresentano come sonnambuli di un eterno presente in cui tutto è immediato, tutto è sempre e solo emozione di un attimo e poi nulla.
Vale per la città-museo quello che, a proposito di “mostre e mostriciattole” (Federico Zeri), scriveva Jean Clair: “Le folle che si accalcano in questi luoghi, assembramenti di persone solitarie non più unite da una fede comune, religiosa, sociale o politica […], hanno trovato nel culto dell’arte la loro ultima avventura collettiva. […] Scomparsa ogni fede, ci si imbatte invece in uno smarrimento comune, in una maggiore solitudine”.
Ma il “culto dell’arte”, per quanto dilettantesco, non è sete di qualcosa di autentico? In fondo la bellezza è lo splendore del vero. Se realmente è nata una superficiale “religione della bellezza” – che ha inflazionato la nota frase di Dostoevskij (senza capirne il significato) – è da disprezzare totalmente? O da comprendere?
Le bellezze artistiche delle nostre città commuovono, ma, al tempo stesso, aprono una ferita perché – davanti ad esse – la nostra misera vita quotidiana grida il suo bisogno di significato, di armonia e meraviglia.
Forse proprio per lo smarrimento e la solitudine, di cui parla Clair, queste folle hanno intravisto nello splendore di tante opere d’arte il balenare di una risposta, di una promessa di felicità.
Certo, tutti abbiamo sempre la memoria ingombra di immagini pubblicitarie e cartoline. Abbiamo spesso “occhi che hanno perduto la capacità di guardare”, di decifrare e gustare ciò che vedono.
Ma forse questi moderni innamorati della bellezza sono – senza saperlo – cercatori dell’assoluto, come pellegrini del terzo millennio. Forse, nell’ammirazione di civiltà del passato, cercano la forza spirituale che le ha rese grandi. O cercano la propria identità e le proprie radici.
“Un popolo che ha radici, un popolo ben lavorato dalla storia è un mistero spirituale”, scriveva Guido Ceronetti nel suo “Viaggio in Italia”. E aggiungeva: “Finché esisteranno frantumi di bellezza qualcosa si potrà ancora capire del mondo. Via via che spariscono, la mente perde capacità di afferrare e di dominare. Questo grande rottame naufrago col vecchio nome di Italia è ancora, per la sua bellezza residua, un non pallido aiuto alla pensabilità del mondo”. Concludeva: “Cos’altro si può essere in un paese come questo se non disperatamente conservatori?”.
Qui incrociamo la politica. Perché non si tratta solo di “conservare” il nostro patrimonio artistico (è il minimo). Si tratta anche di viverlo e farlo vivere. Le radici devono poter portare ancora linfa ai rami per foglie, fiori e frutti nuovi. Altrimenti muoiono.
Antonio Socci
Da “Libero”, 4 giugno 2023