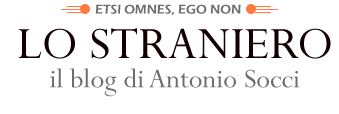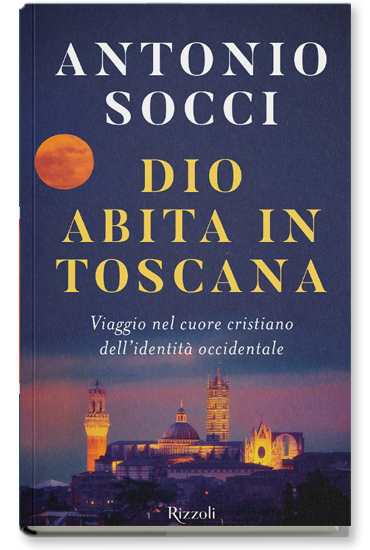STA CAMBIANDO IL VENTO? L’ISTAT RILEVA DESIDERIO DI FAMIGLIA E DI FIGLI FRA I GIOVANISSIMI
La recente indagine dell’Istat sui giovani, il futuro, la famiglia e i figliha sorpreso tutti (lo vedremo). Se son rose fioriranno… Intanto ci ha ricordato una cosa fondamentale: occorrono misure economiche e servizi che favoriscano la natalità, certo, ma la scelta di mettere al mondo figli non è solo una questione economica, è anzitutto conseguenza di un sentimento della vita, individuale e comunitario.
La storia dell’Italia del Novecento lo dimostra: il crollo demografico è cominciato da quando abbiamo raggiunto un benessere che nessuna generazione precedente aveva conosciuto. Ovviamente ci sono molte altre ragioni sociali dietro la scelta di avere o non avere figli. Ma essenziale è il clima culturale e spirituale in cui vive un popolo. Proviamo a ricordare la nostra storia.
Al secondo dopoguerra della “ricostruzione”, mise fine il ’68 della “dissoluzione”. La “ricostruzione”, dal 1945 ai primi anni Sessanta, era stata possibile grazie alla forza morale, al lavoro, ai sacrifici, al senso di comunità (se si vuole patriottico) e all’inventiva dei nostri padri che avevano avuto la fortuna di essere liberati dagli americani, anziché dai sovietici, e alle elezioni del 1948 ebbero l’intelligenza di scegliere il mondo libero anziché il comunismo.
Fu un grande stagione di progresso, un vero “miracolo economico”, la più formidabile rivoluzione pacifica della nostra storia, che – non a caso – coincise con un forte incremento della natalità (nonostante la povertà post-bellica).
Attorno al ’68 raggiunsero la giovinezza quei figli del boom demografico. I loro connotati generazionali furono il rifiuto del passato e dei padri (a cui dovevano tutto) e un’arrogante presunzione giovanilistica: due elementi che trovarono espressione politica nelle idee rivoluzionarie comuniste (che in quegli anni venivano sanguinosamente realizzate nella Cina maoista).
Un’assurdità se si considera che la loro era la prima generazione, nella storia d’Italia, che aveva il privilegio di godere di un diffuso benessere oltreché della libertà e della pace.
Dal ’68 il dogma giovanilista – per il quale i giovani rappresentano il progresso (pure quando professano ideologie deliranti) – non è più stato scalfito, anche perché è stato alimentato da una sinistra che traeva giovamento dal conformismo e dalla faziosità manipolabile dei giovani, privi di esperienza e conoscenze.
Hannah Arendt descrisse bene questo fenomeno: “Una nazione è tanto più vitale quanto più vivo è in essa il ricordo del suo passato (…). L’alto concetto di progresso umano è stato privato del suo senso storico e degradato a mero fatto naturale, per cui il figlio è sempre migliore e più saggio del padre e il nipote più libero da pregiudizi del nonno (…). Alla luce di tali sviluppi, dimenticare è diventato un dovere sacro, la mancanza di esperienza un privilegio e l’ignoranza una garanzia di successo”.
Dalla demonizzazione dei padri e dalla pretesa di cancellare il passato e rovesciare tutto – che caratterizzò il ’68 – si originò una tempesta antropologica, anche nella concezione vita e della famiglia, che portò al crollo demografico tuttora in corso, parte di una crisi più vasta e profonda, di uno smarrimento individuale e collettivo, di un generale spaesamento dei giovani.
Tuttavia, come dicevo, un’indagine dell’Istat, resa nota nei giorni scorsi, sembra registrare un segnale in controtendenza. I dati sono sorprendenti: fra i giovanissimi, il 74,5 pensa che da grande vivrà in coppia, il 72,5% vuole sposarsi e il 69,4% dei ragazzi e delle ragazze desidera dei figli. Fra i più grandi (17-19 anni) quelli che vogliono avere figli aumentano al 73,1%.
Un giornale ha commentato: “un gran desiderio di famiglia fra i giovanissimi italiani”. Non si sa se resisterà, ma perfino l’Istat ritiene che, con questi dati, “una ripresa demografica non sembrerebbe impossibile”.
Cosa succede? Bisognerebbe comprendere quali fattori hanno favorito questo nuovo clima fra i giovani. Probabilmente si percepisce, anche per l’insistenza dei messaggi dell’attuale governo, una forte rivalutazione del valore sociale della maternità e della paternità, pure per la grande ricaduta positiva che l’incremento della natalità avrebbe sull’economia e sulla stabilità del welfare.
Questo diverso sguardo sulla vita, da parte delle giovani generazioni, può essere una svolta storica. Hannah Arendt ha spiegato che, culturalmente, l’atto più “rivoluzionario” – rispetto al corso naturale delle cose – e anche il più creativo che i giovani possano fare è proprio questo: “il miracolo che preserva il mondo, dalla sua normale, ‘naturale’ rovina” scrive la Harendt “è in definitiva il fatto della natalità, in cui è ontologicamente radicata la facoltà di agire. È, in altre parole, la nascita di nuovi uomini e il nuovo inizio, l’azione di cui essi sono capaci in virtù dell’esser nati. Solo la piena esperienza di questa facoltà può conferire alle cose umane la fede e la speranza, le due essenziali caratteristiche dell’esperienza umana che l’antichità greca ignorò completamente. È questa fede e speranza nel mondo” conclude la Harendt “che trova la sua più gloriosa ed efficace espressione nelle poche parole con cui il Vangelo annunciò la ‘lieta novella’ dell’Avvento: ‘Un bambino è nato fra noi’”.
Probabilmente se fosse Giorgia Meloni a pronunciare queste parole si scatenerebbero subito gli attacchi che – come al solito – arrivano fino ad evocare, assurdamente, il ventennio. Invece è stata una grande pensatrice ebrea come Hannah Arendt, forse la mente più brillante che abbia analizzato criticamente il fenomeno totalitario, e che certo non può essere sospettata di simpatie fasciste.
Le sue profonde considerazioni umanistiche dovrebbero essere attentamente meditate. Per ritrovare qualcosa di essenziale che abbiamo perduto.
Antonio Socci
Da “Libero”, 26 maggio 2024
Nelle foto: Hannah Arendt e Giorgia Meloni