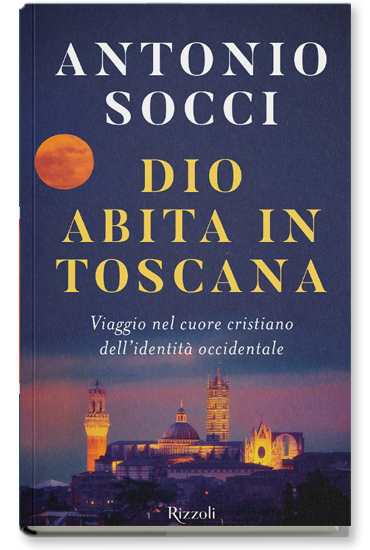I DATI ISTAT SUI CONSUMI CULTURALI DEGLI ITALIANI SONO ALLARMANTI. MA UN POPOLO NON PUO’ VIVERE DI SOLO PIL…. (ALTRIMENTI NON SA PIU’ CHI E’… E LA SOCIETA’ SI DISINTEGRA)
Il sito “Artribune” ha approfondito i dati Istat relativi ai consumi culturali degli italiani. La situazione è allarmante.
La spesa che in media ogni famiglia ha dedicato, nell’arco di un mese, a cinema, teatri e concerti, nel 2019 è stata di 6,23 euro, nel 2020 di 1,70 euro e nel 2021 di 1,57 euro.
Alla voce “musei parchi e giardini” – sempre considerando la spesa mensile di ogni famiglia – abbiamo 1,54 euro nel 2019, nel 2020 precipitiamo a 0,67 euro (è stato l’anno del Covid) e andiamo a 1,13 euro nel 2021.
Libri. La spesa media mensile per la narrativa di ogni famiglia è stata di 5,51 euro nel 2019, di 4,68 euro nel 2020 e di 4,96 nel 2021.
Alla voce “libri non scolastici diversi da quelli di narrativa” abbiamo 0,10 euro nel 2019, addirittura 0,09 nel 2021 e uno sconcertante 0,04 nel 2021.
Giornali. La spesa media per famiglia, ogni mese, è stata di 3,39 euro nel 2019, di 2,70 nel 2020, di 2,76 nel 2021. Per riviste e periodici andiamo anche peggio: 1,95 euro nel 2019, 1,61 euro nel 2020 e 1,61 nel 2021. Praticamente è la morte della stampa, cioè dei giornali e dei libri. La fine di un’epoca storica.
Ovviamente questi dati non dicono tutto. Perché in Italia ci sono molti eventi culturali gratuiti (concerti in piazza, mostre e spettacoli teatrali), abbiamo visite gratuite ai musei ed è vero che si possono leggere libri e giornali senza acquistarli: in biblioteca o (per i giovani) a scuola e a casa. Inoltre la cultura passa gratuitamente anche per la televisione e per internet (oltreché attraverso il sistema scolastico e universitario).
Va pure detto che, negli ultimi anni, le difficoltà economiche hanno avuto un effetto negativo su questo tipo di consumi. Però si tratta di una spesa veramente ridotta al minimo, soprattutto se confrontata con quella per altri beni non essenziali.
La panoramica dell’Istat dunque solleva molte domande. Nella vita di un popolo il Pil non è tutto: la cultura è almeno ugualmente importante.
In un suo celebre discorso, del 1968, Bob Kennedy fra l’altro diceva: “non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice Dow-Jones, né i successi del Paese sulla base del Prodotto interno lordo”.
Kennedy faceva notare che il Pil “comprende anche l’inquinamento dell’aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle… Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari… Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia, la solidità dei nostri valori familiari o l’intelligenza del nostro dibattere. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani”.
La ricchezza di una nazione non è misurabile solo con il Pil. È ricco un popolo che anzitutto conosce e ama la storia da cui proviene, l’arte, la propria civiltà, le città e i paesaggi in cui vive, che ne ricava un’identità e il senso di una missione nel mondo, che è consapevole di sé e del bene che può donare all’umanità e ai posteri.
Il futuro governo di Centrodestra dovrebbe affrontare questi temi con la stessa urgenza con cui affronta quelli economici. Ne va del nostro futuro.
Un’altra considerazione. Si diceva che in quei dati si coglie la fine della parola scritta, il tramonto della civiltà del libro e dei giornali. È solo un innocuo passaggio tecnologico? Oppure il formarsi e l’informarsi sui social porta a un depauperamento grave della qualità del dibattito pubblico?
Il filosofo Guy Debord, noto autore della “Società della Spettacolo”, intuì, già in anni lontani, molte dinamiche della società “informatizzata”.
Nel suo “Commentari sulla società dello spettacolo” scriveva: “Il linguaggio binario del computer è anch’esso un’incitazione irresistibile ad accettare in ogni momento, senza alcuna riserva, ciò che è stato programmato così come ha voluto qualcun altro ma che viene fatto passare come l’origine atemporale di una logica superiore, imparziale e totale. Che bel guadagno di velocità e di vocabolario per giudicare ogni cosa!
(…) Non sorprende quindi che fin dall’infanzia gli scolari vengano iniziati facilmente e con entusiasmo al Sapere Assoluto dell’informatica, mentre ignorano sempre più la lettura che esige un vero giudizio a ogni riga, e che è anche la sola che può dare accesso alla vasta esperienza umana anti-spettacolare. Perché la conversazione è morta e ben presto lo saranno anche molti che sapevano parlare”.
La “conversazione” va intesa anche in senso sociale. Non è forse vero che il discorso pubblico si è ormai incartato nella nefasta logica binaria dei social e, come abbiamo visto anche in questi mesi, tale semplificazione fa perdere la consapevolezza della complessità dei problemi, rendendoci incapaci di argomentare e quindi di dialogare? Parliamo per stereotipi, pregiudizi e slogan (oltreché con insulti).
Qualcosa di simile scrive anche Michel Houellebecq nella sua ultima pubblicazione, “Interventi”, a proposito dei libri: “Un libro può essere apprezzato solo lentamente; implica una riflessione (non tanto nel senso dello sforzo intellettuale, quanto nel senso del tornare indietro); non c’è lettura senza una pausa di riflessione, senza movimento inverso, senza rilettura. Cosa impossibile, e persino assurda, in un mondo in cui tutto evolve, tutto fluttua”.
Lo scrittore francese spiega: “Minati dall’assillo ormai logoro del politically correct, travolti da un flusso di pseudoinformazioni… gli occidentali contemporanei non riescono più a essere lettori; non riescono più a soddisfare l’umile domanda contenuta in un libro posato davanti a loro: quella di essere semplicemente degli esseri umani pensanti e senzienti in prima persona. A maggior ragione” aggiunge Houellebecq “gli stessi non possono svolgere un ruolo analogo di fronte a un altro essere”.
In questa “dissoluzione dell’essere” che è “tragica”, secondo lo scrittore francese, “ciascuno continua, mosso da un rimpianto doloroso, a chiedere all’altro ciò che non può essere: a cercare, come un fantasma cieco, quel tanto di essere che non trova più in se stesso. Quella resistenza, quella permanenza, quella profondità. Da qui l’inevitabile fallimento di ognuno; e la solitudine, che è qualcosa di atroce”.
C’è da riflettere. Per i popoli, come per gli individui, l’essere viene prima dell’avere.
Antonio Socci
Da “Libero”, 11 ottobre 2022