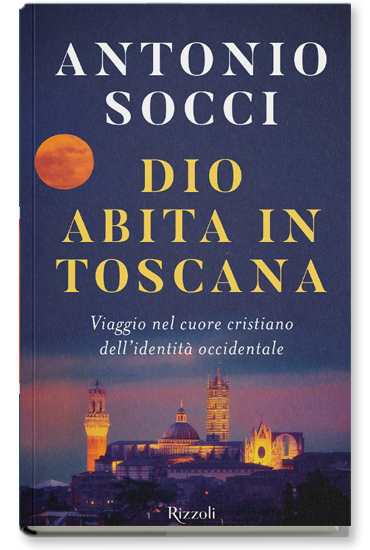LA RAGAZZA CHE FU COMUNISTA. ED E’ IN CERCA DI SE STESSA (E DI DIO).
Ciascuno vede il mondo attraverso le proprie ferite. Ma feriti lo siamo tutti. Perciò, nella sincerità della narrazione di una cicatrice o di una piaga aperta, ci si scopre fratelli.
Solidali pure se si è fatto un itinerario del tutto diverso e si hanno altre storie nel cuore e altre lacerazioni nella carne.
“Mio nonno era comunista” (pp. 134, euro 10, Effigi) affascina per questa sincerità. Non cinica, ma leale e dolorosa. Malgrado il titolo e la copertina dove fa capolino il Bobo di Staino, quello di Monica Granchi non è un pamphlet politico.
E’ un delicato, ironico, struggente romanzo autobiografico che racconta l’itinerario interiore di una ragazzina, nata nel mitico ’68, che diventa donna in una famiglia popolare, di militanti comunisti, a Siena, tra gli anni Sessanta e il Duemila.
Proprio gli anni in cui il Pci di Berlinguer in Italia, dal più vasto successo (nel 1984 addirittura primo partito del Paese), crolla fino alla sparizione del 1990.
Proprio gli anni in cui il socialismo reale passa dalla massima espansione planetaria al collasso (ma i paesi dell’Est sono appena rammentati dall’autrice che semmai legge Kerouac e sogna l’America, detestata dal nonno comunista).
Anni vissuti a Siena, che non era solo una delle città più rosse d’Italia, ma anche la strana e bella città del Palio (se ne parla di sfuggita), oggi famosa soprattutto per il caso Monte dei Paschi.
Un’adolescenza vissuta fra la mitica sede del Pci di viale Curtatone (le Botteghe oscure della città toscana), le aule del Liceo Galilei e quelle della facoltà di Lettere (luoghi del cuore che mi accomunano all’autrice).
ALTRI RIPENSAMENTI
Questo autunno 2013 è un po’ il tempo del ripensamento e della perplessità per la generazione che entrò nel Pci dopo il ‘68, affascinata dal carisma introverso di Enrico Berlinguer.
E’ appena uscito il libro di Michele Serra, “Gli sdraiati”, che mostra lo smarrimento dei padri di fronte al mistero dei figli, ma in particolare quello dei “padri progressisti” che pretendevano di saperla sempre lunga su tutto e si ritrovano in casa degli incomprensibili alieni.
E’ un libro a volte tenero e poetico e, anche se esce dalla penna brillantissima dell’intellettuale che non si mette davvero in discussione, il Mistero della vita attraversa le sue pagine, è nella bellezza delle colline, nei silenzi, nei fiori e nel volto dei figli.
Il libro di Francesco Piccolo, “Il desiderio di essere come tutti”, uscito anch’esso in questi giorni, sembra uno scavo più politico. La pretesa appartenenza al “Club dei giusti”, che da sempre caratterizza gli intellettuali di Sinistra, capaci solo di “indignarsi” e non di trovare soluzioni, è sottoposta a uno sguardo molto severo.
Piccolo si pone domande scomode, s’interroga sul perché in quel Club “mai nessuno metta in discussione le idee” o “si chieda se c’è qualcosa che non funziona” o “perché gli altri riescano a penetrare i desideri di una quantità di gente superiore alla nostra. Mai che andiamo a curiosare chi sono, cosa fanno, se nascondono una virtù che non abbiamo. Siamo assolutamente sicuri di aver ragione e che gli altri hanno torto, ma si ravvederanno”.
Sono due libri che disegnano, come ha scritto Concita De Gregorio, “la parabola triste di una sinistra perduta”. Ma Serra e Piccolo appartengono a quell’élite che nel “Palazzo” del Partitone – ricorda ironicamente Monica Granchi – stava all’ultimo piano: gli intellettuali.
LA RAGAZZINA
Lei invece è la ragazzina della portineria, la nipote del nonno comunista che per anni è stato il centralinista e portiere-tuttofare della sede del partito, nella rossa Siena.
Lei è la ragazzina che se ne stava su un tavolino a fare i compiti o i disegni, mentre il nonno – all’ingresso – smistava un gran traffico di militanti e dirigenti.
La ragazzina per la quale quelle “botteghe oscure” senesi erano una grande famiglia che non c’è più. E che – da adolescente, con tutto il parentado – lavorerà ogni estate per un mese alla Festa dell’Unità.
Il suo è un diario intimo che diventa autobiografia collettiva solo di rimbalzo. L’autrice infatti non concede quasi nulla alla storia ufficiale. L’unico evento pubblico è la morte di Berlinguer. Ma anch’esso è vissuto come dramma interiore.
Tutto in queste pagine è intimo, è un emergere dell’anima e dei suoi incontenibili desideri di libertà in spazi troppo angusti e incapaci di decifrare quel grido, che esplode già dalla lettura adolescenziale di una vita di Vittorio Alfieri.
La libertà è il grido di un’anima che si sente esiliata. O negata. Già, l’anima Con un’impietosa battuta, a proposito dei quadri di una parente, l’autrice sospira: “nessun sentimento abitava quelle tele in cui riconoscevo solo abili copie senz’anima. Ma l’anima era un concetto sopravvalutato per i comunisti”.
L’ANIMA
Non che la protagonista non sia stata una convinta militante, solo che non poteva trovarsi appagata dall’aspirazione della famiglia operaia, appena inurbata (una di quelle famiglie che dal 1945 hanno portato il Pci a Siena a percentuali altissime): il sogno di avere finalmente un (modesto) appartamento, un salotto ammobiliato, un televisore e figli col titolo di studio.
Tutte mete sacrosante, riconosce l’autrice, aspirazioni nobilissime della povera gente, a cui il Partito cercava di provvedere come un padre di famiglia. Un’aspirazione alla dignità o semplicemente al benessere.
Ma mete piccolo-borghesi (seppure chiamate “uguaglianza”) che, raggiunte, non esauriscono la vastità del desiderio umano, così sentito dalla protagonista adolescente, che si trova a constatare: “credo che una dose di infelicità fosse connaturata all’idea stessa di comunismo. Come una tassa da pagare”.
In realtà era il limite della politica in sé, e per la protagonista il Partito era la politica. Perché – nonostante le illusioni del passato – non può essere la politica a rispondere all’invincibile esigenza di felicità che sale dall’anima.
La politica non parla a quella profondità insondabile e misteriosa, abitata da domande vertiginose, quella profondità dove ci si scopre soli e bisognosi di “essere speciali”, di sentirsi amati.
E’ da quelle profondità che l’anima grida anche con linguaggi estremi e drammatici, come l’anoressia della protagonista, a 16 anni. O accende il suo cuore quando legge Baudelaire, Pavese o Pessoa…
Così, in “Mio nonno era comunista”, la politica torna al suo posto, limitato e laico: quello di “tentare di risolvere i problemi”. Nulla di più. Mentre “per mio nonno il comunismo era stato come una religione. Di sicuro era stato la nostra famiglia allargata”.
PANORAMI DI FELICITA’
Tuttavia nell’arcipelago di famiglie, zie, nonni e nipoti che popola il libro, fa capolino anche un altro orizzonte religioso, quello dei bisnonni paterni, “i miei nonni cattolici”.
Da loro, nella campagne di Scansano, la protagonista trascorse i primi sei anni felici della vita. I ricordi sono struggenti: il latte appena munto, le uova benedette di Pasqua…
“Ci sostenevamo. Ci facevamo compagnia. I grandi badavano ai più piccoli e i più piccoli aiutavano gli anziani. O forse era che eravamo cattolici. Quella parte della mia famiglia lo era. E anch’io, per volontà di mia nonna, sono stata battezzata. Ma il nostro era un cattolicesimo intimo, alla buona. Lontano dalle punizioni severe. Più attento all’idea di misericordia che a quella di peccato. Lontano soprattutto dal rigore. Rigore che la mia famiglia comunista aveva invece fatto suo”.
Purtroppo, per l’autrice, quella misericordia resta solo un remoto ricordo di infanzia, una specie di sogno felice.
Che non è mai diventato – come invece è accaduto a me, negli stessi luoghi – un incontro, un incontro vivo nell’età delle grandi domande, un incontro capace di trovarti quando ti perdi negli abissi della giovinezza.
Però le ferite di questo libro – così ben scritto – sono anche feritoie da cui si possono intravedere di lontano panorami diversi, terre sognate, mari mai attraversati, paesaggi dove i boccioli di un tempo fioriscono.
Antonio Socci
Da “Libero”, 8 novembre 2913
Facebook: “Antonio Socci pagina ufficiale”