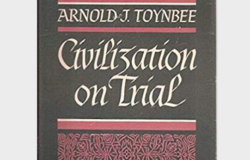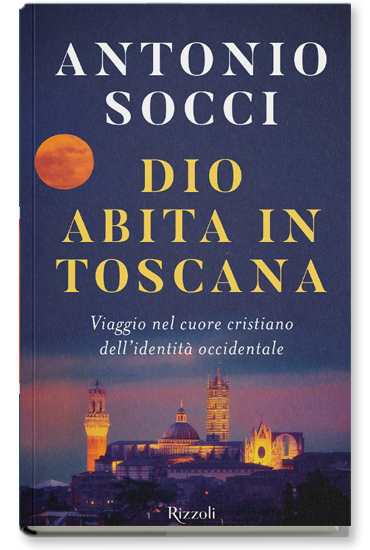“QUALCOSA D’INAUDITO ACCADRA’ IN QUEL CAMPO DI GRANTURCO E IN QUELLA VIGNA…” (PENSIERI ESTIVI SU CESARE PAVESE, LA MEMORIA, L’INFANZIA, LA POESIA E IL SENSO DELLA VITA)
“Il giorno in cui mi fermai ai piedi di un campo di granturco e ascoltai il fruscio dei lunghi steli secchi mossi nell’aria, ricordai qualcosa che da tempo avevo dimenticato. Dietro il campo, una terra in salita, c’era il cielo vuoto. ‘Questo è un luogo da ritornarci’, dissi, e scappai quasi subito, sulla bicicletta, come se dovessi portare la notizia a qualcuno che stesse lontano. Ero io che stavo lontano, lontano da tutti i campi di granturco e da tutti i cieli vuoti”.
“Feria d’agosto” di Cesare Pavese è un libro da leggere. In vacanza o no. Anche perché, come suggerisce questa pagina, oltre a raccontare i ricordi dell’estate in campagna al tempo della civiltà contadina, è una suggestiva esplorazione della memoria, dell’infanzia, del mito, del linguaggio e della poesia. Indaga il mistero dell’essere nostro.
La pagina sul campo di granturco rimanda a un aspetto decisivo dell’infanzia, il non conoscere il nome delle cose:
“Nessun bambino ha coscienza di vivere in un mondo mitico… nessun bambino sa nulla del ‘paradiso infantile’ in cui a suo tempo l’uomo adulto s’accorgerà di esser vissuto. La ragione è che negli anni mitici il bambino ha assai di meglio da fare che dare un nome al suo stato. Gli tocca vivere questo stato e conoscere il mondo”.
Quando comincerà a rendersi conto di non conoscere neanche se stesso, di non sapere chi è, né come trovarsi, quando intuirà che è proprio lui quello “che sta lontano” dai campi di granturco a cui voleva portare la notizia, potrà capitare che qualcosa lo suggestioni e certe emozioni tornino ad affollare il suo presente – come “mémoire involontaire” – e facciano affiorare ricordi e impressioni (la “madeleine” di Proust) e gli sembrerà che le cose parlino a lui, di lui, dicendo il suo nome, e tutto sarà avvolto dall’“aura” descritta da Walter Benjamin nel suo celebre saggio su Baudelaire:
“chi è guardato o si crede guardato alza gli occhi. Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare. Questa dotazione è una scaturigine della poesia”.
Da ragazzi non ci accorgevamo di essere “guardati” e chiamati dalle cose. La poesia è nel nostro sguardo successivo, nel ricordo. Ecco perché Pavese annota: “Bisogna sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo”.
La letteratura – dando un nome alle cose e alle emozioni – ci fa accorgere della realtà facendoci scoprire noi stessi, ci fa riappropriare di esperienze che avevamo accantonato nel ripostiglio delle cose senza significato. Ci fa intuire che eravamo “guardati” e non ce n’eravamo accorti. Eravamo attesi.
Le cose che ti “chiamano” appaiono belle e piene di una promessa, la stessa intuita, senza decifrarla, nel campo di granturco. Così (più avanti nel libro) Pavese scrive:
“Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo è una vista familiare, eppure le cortine dei filari semplici e profonde appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa dissodata, le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo… Tutto ciò è familiare e remoto – infantile, a dirla breve, ma scuote ogni volta, quasi fosse un mondo. La visione s’accompagna al sospetto che queste non siano se non le quinte di una scena favolosa in attesa di un evento che né il ricordo né la fantasia conoscono. Qualcosa d’inaudito è accaduto o accadrà su questo teatro”.
Pavese sa cogliere – come pochi altri – l’attesa in cui sta tutto il mistero dell’esistenza.
Antonio Socci
Da “Libero”, 20 agosto 2022