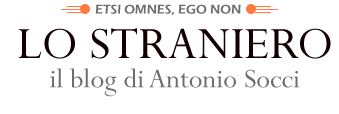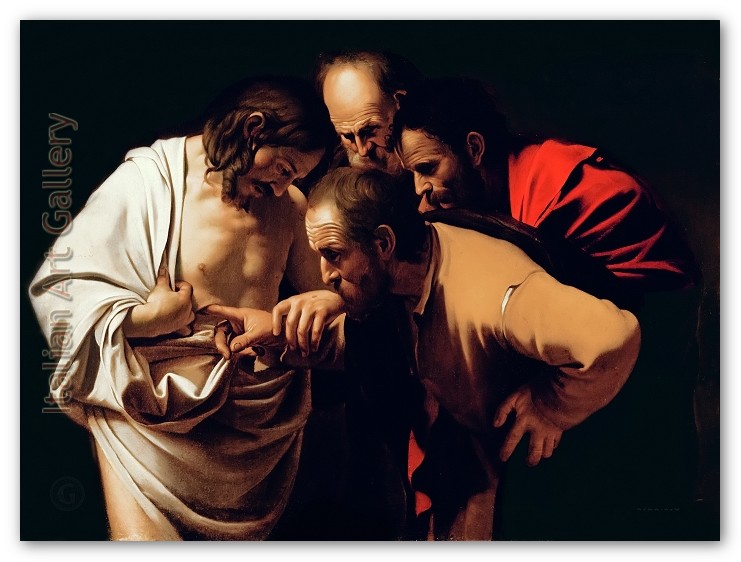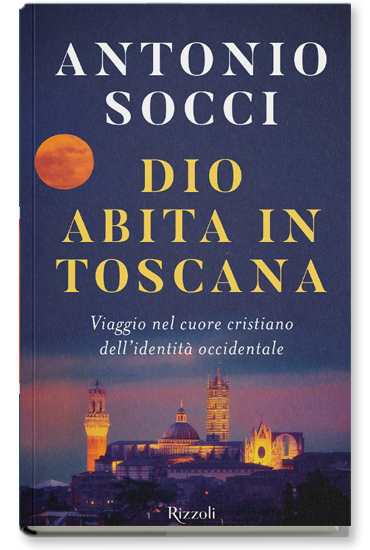I VANGELI, CRONACHE FEDELI DI FATTI VISTI E TOCCATI CON MANO
Il filologo Luciano Bossina tiene oggi a Torino una conferenza, in parte anticipata da Avvenire (26/11), sulla “physis”(natura): “nella letteratura e nella filosofia greca il termine physis ricorre ovunque, e si carica di valori profondi e sempre mutevoli”.
Ma – aggiunge Bossina – gli studiosi ebrei che, nel III secolo a.C., tradussero in greco la Bibbia (la Bibbia dei Settanta) “in tutto l’Antico Testamento non hanno mai trovato un termine equivalente… Dunque la ‘natura’ nell’Antico Testamento non c’è”. Compare solo nei libri che furono “composti direttamente in greco”.
E il Nuovo Testamento? Bossina spiega: “la parola ‘natura’ nei Vangeli non c’è. E Nemmeno negli Atti degli Apostoli. Gesù non l’ha mai pronunciata”.
Com’è noto i codici più antichi dei Vangeli a noi pervenuti sono in greco e Bossina constata: “nessuno dei quattro evangelisti, nell’atto di scriverne in greco, ha mai pensato che la physis potesse entrare in gioco”.
Perché? C’è una risposta. Sembra che i Vangeli, in realtà, siano stati scritti in una lingua semitica (ebraico o aramaico) e i codici a noi pervenuti siano traduzioni in greco. Proprio come la Bibbia dei Settanta. È un tema attorno al quale sono scoppiate polemiche fra studiosi.
IL GIALLO DEI VANGELI
Già il santo vescovo Papia di Ierapoli (70-130), con altri Padri, parlò del Vangelo di Matteo scritto in ebraico. Anche eruditi ebrei hanno rilevato il substrato semitico dei Vangeli. La cui redazione, conseguentemente, avvenne vicino ai fatti narrati (quando la comunità cristiana era pressoché tutta in terra d’Israele) e vivevano i testimoni oculari.
Ma in epoca moderna s’impose un razionalismo che per spiegare la nascita del cristianesimo – dando un colore leggendario agli episodi soprannaturali dei Vangeli (come miracoli e profezie) – sostenne che erano trascorsi decenni fra la vita di Gesù e la composizione dei Vangeli, che dunque non avevano a che fare con i testimoni oculari. Sarebbero state le comunità ellenico-pagane a comporli (in greco). Questa distanza temporale spiegava la mitizzazione della figura di Gesù, scavando un abisso fra il “Gesù della storia” e il “Cristo della fede”.
Ma come spiegare allora i tanti semitismi presenti nel testo greco dei Vangeli e rilevati già da Erasmo da Rotterdam? Nel corso del Novecento molti studiosi ne hanno scoperti una quantità.
Finché un grande erudito, padre Jean Carmignac (1914-1986), specialista di aramaico ed ebraico antico, fondatore tra l’altro della “Revue de Qumran”, documentò che sotto il greco dei Vangeli c’era davvero un originale semitico. Cosa che lo indusse a datare i Vangeli molto a ridosso degli eventi narrati e questo ne esalta la storicità. Lavorò per anni a un poderoso studio (interrotto dalla morte) i cui risultati anticipò in un libro del 1983, La nascita dei Vangeli sinottici.
LA SVOLTA
La sua tesi suscitò molte polemiche, ma tanti altri studiosi l’hanno sostenuta. Il professor Paolo Sacchi, per anni docente di Ebraico e Aramaico all’Università di Torino, mi disse in un’intervista: “Che il testo greco dei Vangeli sinottici derivi da una traduzione di scritti ebraici, per me è semplicemente ovvio. È così evidente. Basta conoscere il greco e l’ebraico per accorgersene”.
PS Una delle tante curiosità che si possono citare: lo studioso ebreo Pinchas Lapide ha fra l’altro spiegato che in realtà Gesù (in Mt 19, 24) non parla di un “cammello” (in ebraico gamal) che non passa dalla cruna dell’ago, ma di una gomena (gamta). Chi tradusse in greco confuse le due parole simili.
Antonio Socci
Da “Libero”, 30 novembre 2024