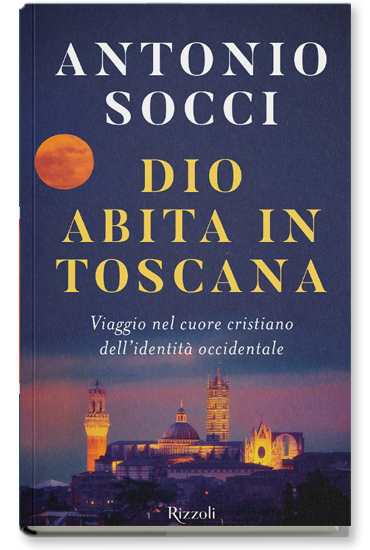PERCHE’ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CI FA CAPIRE CHE NOI ABBIAMO UN’ANIMA IMMORTALE
Quasi ogni giorno arrivano notizie mirabolanti dal mondo dell’Intelligenza Artificiale. La più recente dice che – immagazzinando una miriade di dati – potrebbe prevedere la morte precoce di un individuo con buona approssimazione. Salvo imprevisti che però nella vita accadono sempre.
In ogni caso stanno elaborando pure programmi di IA per imitare perfettamente le caratteristiche comunicative di una persona morta e quindi metterci in grado di “parlare” con questo “fantasma” tecnologico avendo la sensazione (illusoria) di dialogare con la persona che si è perduta (si chiama thanabot).
Al di là di queste trovate, riflettere sull’IA può svelarci – sia pure indirettamente – qualcosa di essenziale su di noi, sulla nostra mente, sulla nostra morte e sul “dopo-la-morte”, perché ci costringe a chiederci cos’è la coscienza, cos’è il nostro io.
Douglas Hofstadter è stato fra i primi a studiare l’intelligenza artificiale. Divenne famoso nel 1979 vincendo il premio Pulitzer per il libro “Gödel, Escher, Bach”, in cui cercava di capire “il modo in cui il cervello elabora i concetti” e come, dai nostri meccanismi neurologici, emergano la conoscenza e l’autocoscienza.
Nel 2007 ha pubblicato “Anelli nell’io: Che cosa c’è al cuore della coscienza?”, dove approfondisce la sua tesi secondo cui l’anima (il proprio sé, l’io) è un miraggio, un’illusione prodotta dall’hardware del cervello.
Ma tutto il libro è percorso da un dramma personale che racconta nel capitolo intitolato: “Alle prese con il mistero più profondo”. Inizia così: “Nel dicembre 1993, quando era appena passato un quarto del mio anno sabbatico in Italia, a Trento, mia moglie Carol morì all’improvviso, in pratica senza segni premonitori, di un tumore al cervello. Non aveva ancora 43 anni, e i nostri figli ne avevano soltanto 5 e 2. Ne fui devastatoin una misura che non avrei mai immaginato possibile prima del nostro matrimonio. Dietro quegli occhi c’era stata un’anima splendente e luminosa, e quel fulgore si era improvvisamente eclissato. La luce si era spenta”.
Lo studioso racconta la sua straziante esperienza: “Nei mesi surreali successivi alla tragedia della morte improvvisa di Carol, mi ritrovai a essere perseguitato senza sosta dal mistero dello svanire della sua coscienza, cosa che non aveva il benché minimo senso per me, e dal fatto innegabile che continuavo a pensare a lei al presente, cosa anche questa che mi disorientava”.
Così la domanda sull’io, la coscienza, su dov’è il proprio sé, acquistarono drammaticità nella sua riflessione. Perché inevitabilmente tutti gli esseri umani che perdono una persona amata si arrovellano chiedendosi dov’è quel “tu” che poco prima era vicino e visibile. Non esiste più perché il suo corpo è morto?
È la domanda centrale: noi siamo soltanto il nostro organismo fisico? Il nostro pensiero e il nostro “io” sono prodotti dal fascio di atomi che compongono i neuroni e muoiono con il corpo? Martin Gardner – celebre per la sua rubrica su Scientific American – recensendo, con rispetto e stima, il libro di Hofstadter – muove un’obiezione: “Hofstadter ritiene di aver spiegato la coscienza. Purtroppo l’ha soltanto descritta”.
Dopo essersi chiesto “quale incredibile abracadabra fa sì che questo groviglio di filamenti intrecciati fra loro”, i neuroni, “divenga cosciente di se stesso come essere vivente, capace di amare e di odiare, di scrivere romanzi e sinfonie… con la libertà di scegliere se fare il bene o il male”, alla fine rivela: “faccio parte di un gruppetto di pensatori detti misteriani, che comprende filosofi come Searle, Thomas Nagel, Colin McGinn, Jerry Fodor, e anche Noam Chomsky, Roger Penrose e alcuni altri”.
Ebbene, prosegue, “siamo tutti convinti che tra i filosofi e gli scienziati viventi nessuno abbia la più pallida idea di come la coscienza e il libero arbitrio, suo inseparabile compagno, possano emergere – come senza dubbio fanno – da un cervello materiale”.
Del resto, considerando il cervello di uno scimpanzé, Gardner osserva: “sebbene il nostro DNA sia quasi identico a quello di uno scimpanzé, non c’è modo di insegnare il calcolo differenziale a uno scimpanzé, e neanche di fargli capire la radice quadrata di 2”.
Perché solo il cervello umano – fisicamente così simile a quello dello scimpanzé – ne è capace? Peraltro se l’autocoscienza nell’uomo sgorga dalla materia perché non si produce anche nel computer? La macchina è capace di immagazzinare una quantità impressionante di dati, forniti dall’uomo, e di elaborarli offrendo risposte e calcoli, ma non ha un pensiero, né un’autocoscienza.
L’anno scorso, sul New York Times, Noam Chomsky, celebre linguista e scienziato, in uno splendido articolo intitolato “La falsa promessa di ChatGPT”, ha scritto che l’IA è “una cosa irrilevante se confrontata con la mente umana”.
Ma cos’è dunque la mente umana? Cos’è l’uomo? C’è un italiano che è all’origine della rivoluzione informatica: Federico Faggin (ideatore del primo microprocessore commerciale).
Ha scritto un libro intitolato “Irriducibile” in cui afferma che nell’uomo c’è qualcosa di – appunto – irriducibile che il computer non può avere: “se crediamo che la materia inanimata possa spiegare tutta la realtà, sosteniamo un assunto già falsificato dal fatto che siamo coscienti”, “ci sentiamo ripetutamente dire che siamo dei robot biologici”, ma in realtà “siamo esseri spirituali temporaneamente imprigionati in un corpo fisico simile a una macchina”.
L’unicità dell’uomo nell’universo, ciò che nessuna intelligenza artificiale avrà mai, sta in ciò che già i filosofi greci avevano intuito per via razionale: l’anima. Quello è il nostro io immateriale, la coscienza che sopravvive al corpo.
È ciò che ci rende capaci di domandarci il perché delle cose, di valutare, studiare e giudicare noi stessi, di scoprire le leggi dell’universo, di costruire macchine potenti (come i computer), di creare bellezza, di amare o di odiare, di fare il bene o il male. È il pensiero, il linguaggio e la coscienza di sé. L’anima è un’evidenza “cartesiana”.
Antonio Socci
Da “Libero”, 21 gennaio 2024