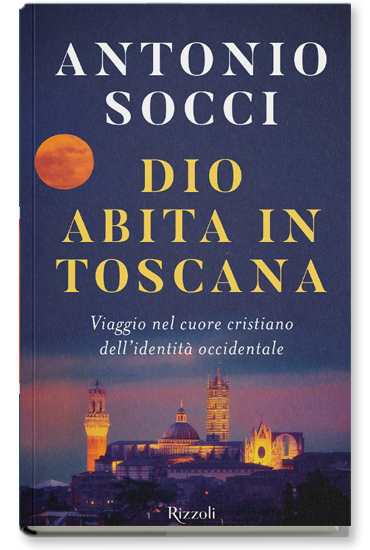UN CENTENARIO UNISCE DON GIUSSANI E TRE SCRITTORI: IL CROLLO DELLA CRISTIANITA’ E LA GEMMA D’APRILE SULLA QUERCIA MILLENARIA
Il centenario di don Luigi Giussani – nato il 15 ottobre del 1922 – accomuna quest’anno il fondatore di Comunione e Liberazione a personalità apparentemente a lui lontane. Infatti in quel 1922 nacque anche, il 5 marzo, Pier Paolo Pasolini. Inoltre morirono Giovanni Verga, il 27 gennaio, e Marcel Proust, il 18 novembre.
In realtà qualcosa di profondo li unisce, una stessa intuizione della modernità che ha a che fare con la fine della cristianità.
Giovanni Verga è il più grande romanziere italiano dell’Ottocento, insieme ad Alessandro Manzoni. Di solito lo si rinchiude nello schema del “verismo” e lo si inquadra in un orizzonte ateo e materialista. Ma è davvero così?
È uscito il libro del filologo e critico letterario Giuseppe Savoca, “Verga cristiano dal privato al vero” (Olschki). Savoca nota che il termine “peccato” è “marcato dall’uso verghiano… è categoria interna al mondo verghiano, alla sua antropologia e alla sua idea della storia, di ogni storia, quella del singolo come quella di una famiglia o di gruppi sociali e, in fondo, dell’uomo nella sua essenza, e al di là di ogni sua concretezza storico-sociale”.
Il filologo ritiene “criticamente molto produttivo investigare le diverse fenomenologie di questo tema, non escludendo aprioristicamente la dimensione religiosa e cristiana dello scrittore e dei suoi personaggi su cui resta molto da capire e da mettere in luce. Su questa strada si arriverà forse a rileggere tutto il mondo verghiano come una dolente risposta al trauma della cosiddetta morte di Dio: trauma che è il prezzo pagato dall’uomo occidentale al trionfo della modernità. Verga e la sua Sicilia non si rassegnano alla scristianizzazione e alla caduta e perdita di valori che sembrano caratterizzare la modernità”.
Marcel Proust (1871-1922) vive in un mondo che parrebbe l’opposto della Sicilia verghiana: la laicissima Francia della Terza Repubblica, la borghesia parigina degli anni che vanno dalla Comune di Parigi alla Prima guerra mondiale.
Rientra nel clima di quel tempo la legge del 1905 sulla separazione fra stato e chiesa che intendeva sconsacrare le splendide cattedrali medievali di Francia. Proust intervenne, nel 1904, sul “Figaro” proprio su “La morte delle cattedrali”.
Lui – che pure era ateo/agnostico – inorridiva per l’idea di trasformare le cattedrali francesi in “semplici pezzi da museo”. Vedeva la Francia scristianizzata come “un’arida riva dove gigantesche conchiglie cesellate apparirebbero in secca, svuotate della vita che in esse aveva abitato e incapaci di recare all’orecchio che si chinasse su di esse il vago rumore di un tempo”.
Questa metafora delle cattedrali come conchiglie è molto significativa nella sua “Recherche”. Proust ha nostalgia dei riti cattolici nelle cattedrali: “quanto dovevano essere belle queste feste ai tempi in cui erano i sacerdoti che celebravano le messe… perché avevano, nella virtù di questi riti, la stessa fede degli artisti che scolpirono le cattedrali”.
E “mai uno spettacolo paragonabile a questo, uno specchio gigantesco della scienza, dell’anima e della storia fu offerto agli sguardi e all’intelligenza dell’uomo… si può dire che una rappresentazione di Wagner a Bayreuth è men che nulla accanto alla celebrazione della messa solenne nella Cattedrale di Chartres”.
La “Recherche” proustiana sarà piena di cattedrali francesi, da Chartres, ad Amiens, da Bourges a Troyes e tante altre. È stato Alberto Beretta Anguissola nel volumetto, “Proust e la Bibbia” (San Paolo), a decifrare questa nostalgia e a scoprire il “criptotesto” fatto di “allusioni, esplicite o implicite, alla Bibbia, ai simboli cristiani e alla liturgia cattolica. La ‘ricerca del tempo perduto’ è un pellegrinaggio”. La “ricerca” è l’antica “Quest”, la ricerca del Dio perduto.
Ma il crollo della cristianità era appena iniziato e si sarebbe poi consumato nella seconda parte del XX secolo.
Pier Paolo Pasolini ne percepì come nessun altro la drammaticità, fin dagli anni Sessanta: “quei famosi duemila anni di imitatio Christi” scriveva “non hanno più senso, appartengono a un altro mondo, negato, rifiutato, superato: eppure sopravvivono”.
E, sebbene “anticlericale”, ripeterà che sopravvivono in lui, come nostalgia delle bellezza, di un mondo perduto e come atroce mancanza: “Manca sempre qualcosa, c’è un vuoto/ in ogni mio intuire…/mai fui così volgare come in questa ansia/ questo ‘non avere Cristo’”.
Un grido che dopo il ‘68 esplode poi nei suoi fiammeggianti interventi sul “Corriere della sera” degli anni Settanta che fanno scandalo (per esempio per la sua posizione contro l’aborto).
Demitizza tutta la retorica progressista raccontando con struggimento la fine improvvisa della civiltà contadina “dopo circa 14mila anni di vita” e la mutazione antropologica in atto, l’avvento di un “nuovo Potere” che impone “l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo”, la falsa tolleranza di “un edonismo neo-laico ciecamente dimentico di ogni valore umanistico”, un “nuovo Potere” che con questa omologazione spazza via le culture popolari e le diverse identità, ovviamente “gettando a mare cinicamente i valori tradizionali e la Chiesa stessa che ne era il simbolo”.
Don Giussani, leggendo questi interventi si sentì in totale consonanza, lui che già nei primi anni Cinquanta – giovane prete, con una fede intelligente e luminosa – aveva scoperto che, in quell’Italia del “miracolo economico” dove la Dc governava e l’Azione Cattolica pacelliana portava migliaia di ragazzi in piazza San Pietro, in realtà fra i giovani non c’era più nessuna consapevolezza autentica di cosa è la fede cristiana.
In sostanza stava crescendo un povero popolo di giovani con più soldi, ma senza più Gesù Cristo e senza una domanda vera sul senso della vita.
È per questa intuizione che decide di lanciarsi nell’appassionata avventura che avrebbe affascinato migliaia di studenti milanesi e poi – soprattutto dopo il ’68 – dilagherà in tutta Italia e tanti altri paesi.
Giussani metteva a tema anzitutto l’inestirpabile sete di felicità dell’uomo, che resta sempre inappagata. Tuttavia – diversamente da tutti i nostalgici della cristianità perduta (fra cui i grandi scrittori cattolici francesi eccetto Péguy) – non c’è in lui il rimpianto di un passato, ma l’annuncio di un fatto presente: Cristo è, oggi, l’unica vera e piena risposta a quel desiderio di felicità, dunque – diceva – “vieni e vedi”.
Farà spesso riecheggiare le parole di Péguy: “Egli è qui./ E’ qui come il primo giorno./ E’ qui fra di noi in tutti i giorni della sua eternità./Il suo corpo, il suo medesimo corpo…/ I suoi occhi, i suoi medesimi occhi…”.
Migliaia di giovani scoprono che l’amicizia di Cristo (e fra di loro) fa fiorire la loro umanità e la loro vita. Giussani spiegherà: “chi ha avuto la grazia di partecipare all’esperienza cristiana lo sa bene: non esiste nulla di paragonabile a questa amicizia nel destino. Non ci fa paura nulla. Nemmeno la crisi della Chiesa”.
Scrittori come Verga, Proust, Pasolini hanno raccontato come finisce una società cristiana. Giussani ha mostrato come l’avventura di Cristo nel mondo sempre ricomincia. Da secoli. Per grazia. Come una cosa nuova, una gemma d’aprile su una quercia millenaria.
Antonio Socci
Da “Libero”, 30 gennaio 2022