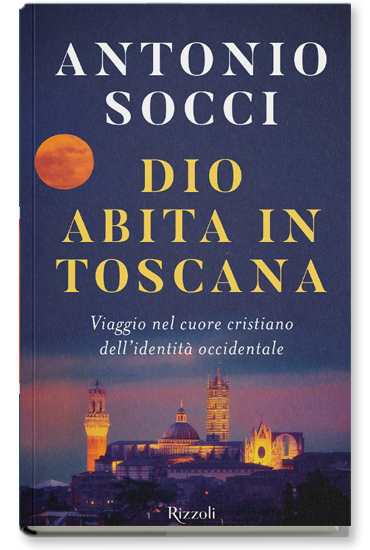IL COMUNISMO VERO CHE I “COMUNISTI DA DIVANO” DI CASA NOSTRA NON VOGLIONO VEDERE
“Perché ho scritto ‘Le favole del comunismo’ e perché questo titolo fa arrabbiare tanto tanti italiani”. Ha iniziato così Anita Likmeta, l’altroieri, il suo post polemico su X. La sua è una storia di immigrazione che però non piace a certi progressisti di casa nostra.
Tutto comincia con la madre Ela, sarta, che al crollo del regime comunista di Tirana scappa con due figli piccoli in Italia, dove sbarca nel 1991 con la famosa nave che arrivò a Bari carica di migliaia di albanesi. La giovane donna trova lavoro – appunto come sarta – e nel 1997 torna in Albania per prendere l’altra figlia rimasta con i nonni, che è Anita.
La quale, arrivata da noi all’età di 11 anni, impara l’italiano e s’impegna molto nello studio: frequenta il liceo classico, ottiene varie borse di studio e si laurea in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma.
Lavora per qualche tempo a Parigi, come babysitter, per imparare il francese, quindi fa l’interprete (parla ormai sei lingue) e poi diventa imprenditrice. Oggi è una donna di successo, perfettamente integrata in Italia.
S’impegna in politica con +Europa, ma a Natale del 2023 – scrive il Corriere della sera – abbandona questo partito che “aveva postato sui social delle immagini di presepi in chiave di famiglia non tradizionale: uno con due Giuseppe e il Bambino, un altro con due Marie e il Bambino e uno con la sola Madonna e il Bambino (entrambi neri), a rappresentare una madre single”. La didascalia recitava: “Il bello delle tradizioni è che possono cambiare! Buone feste da +Europa”.
Anita Likmeta se ne va con questa dura dichiarazione: “Se +Europa pensa di difendere la diversità con ammiccamenti ipocriti alla tradizione, io per il ruolo della Madonna lesbica non sono disponibile. Addio a +Europa e buon suicidio politico (non assistito)!”.
Adesso l’imprenditrice ha pubblicato un libro intitolato Le favole del comunismo (Marsilio). Racconta – talora con i toni del realismo magico – l’infanzia di una bambina nell’Albania degli anni Ottanta e Novanta: una vita di miseria, squallore, oppressione e poi il crollo del regime. Tutto attraverso gli occhi di una fanciulla. È un libro struggente.
Ma l’altro ieri, su X, l’autrice ha scritto quel lunghissimo post che – dopo l’esordio citato – prosegue così: “Potrei partire da questo. Dallo spiegare a me stessa, prima di tutto, perché questo libro abbia generato una ventata di odio così potente nei miei confronti, nei confronti cioè di una che, di ‘comunismo’, sa qualcosa davvero, avendolo sperimentato sulla propria pelle, a differenza di coloro che, qui in Italia, lo hanno studiato sui libri o immaginato nelle loro camerette”.
Poi aggiunge: “In questo dibattito che ho suscitato mio malgrado ho potuto così conoscere una delle categorie più diffuse in questo paese, ovvero quella dei comunisti immaginari. Persone che stanno tutto il giorno attaccate ai prodotti del turbocapitalismo, come gli smartphone, i social media e le piattaforme varie, e che, dall’alto di questa macroscopica contraddizione, vogliono insegnare a me cosa devo pensare di qualcosa che ho conosciuto da vicino, e quanto sia marcio e cattivo quell’Occidente nel quale tuttavia sguazzano e prosperano come pesci nel mare”.
La Likmeta ritiene che il vecchio Pci fosse migliore dei “comunisti immaginari” di oggi (qui va detto che non è stata ben informata). Poi aggiunge che “questi nuovi rivoluzionari da tastiera hanno fatto università nelle quali marxisti altrettanto immaginari proclamano ideali di purezza e giudizi trancianti proprio mentre le loro azioni e la loro vita riflettono tutt’altra attitudine” e dopo una digressione sulle università (in difesa della “meritocrazia”) torna ad attaccare quelli che definisce “miei odiatori seriali… Comunisti in pubblico, pronti a recintare col filo spinato il salotto buono di casa loro in privato”.
Infine ricorda una delle “favole del comunismo albanese”, quella dell’uguaglianza: “Anche lì l’uguaglianza restava una favola bella raccontata dal regime: la nomenclatura del partito, le famiglie dell’aristocrazia amministrativa di Tirana, godevano di privilegi e agi che noi pezzenti di campagna non potevamo neanche immaginare(…). Ma i comunisti immaginari italiani continuano a volermi insegnare, dalla tastiera del loro Iphone 12, che il male è l’Occidente, nel quale hanno però abbastanza tempo libero da perdere per insultarmi sui social, colpevole come sono di aver raccontato qualcosa della vita di una bambina albanese cresciuta in mezzo a 800 mila inutili bunker”.
È curioso che il libro di Anita Likmeta abbia suscitato polemiche, perché è scritto con delicatezza narrativa. Anche se il comunismo appare in tutto il suo ottuso squallore, è pur sempre letteratura.
Per avere invece una denuncia realista di quello che è stato il comunismo albanese nei decenni di Enver Hoxha, il tiranno che studiò nell’università francese (fortemente antireligiosa), i “comunisti immaginari” italiani dovrebbero leggere il formidabile libro di Don Simon Jubani (1927-2011), Dal profondo dell’inferno ho visto Gesù crocifisso. Un sacerdote nelle prigioni comuniste albanesi (Cantagalli).
Questo coraggiosissimo uomo di Dio racconta i suoi ventisei anni di carcere nel primo Stato ateo al mondo: le torture, le atrocità, i massacri del regime, il clima di terrore in cui hanno tenuto per decenni un intero popolo piagato dalla fame e dalla miseria.
Tornato in libertà dal 1990 don Simon ha raccontato tutto al mondo, le chiese rase al suolo, i preti torturati e i martiri: “Quanto a me, non mi hanno ucciso, ma volevano che morissi lentamente. Ho scontato ventisei anni di carcere, vivendo del miracolo della preghiera quotidiana a Maria (…). Appena uscito di prigione, la gente venne a chiamarmi per celebrare la prima Messa in pubblico. (…) Dio ha liberato il Paese dalla dittatura”.
Un racconto impressionante che i nostri “comunisti immaginari” non vorranno leggere mai. Per non sapere.
Antonio Socci
Da “Libero”, 4 luglio 2024