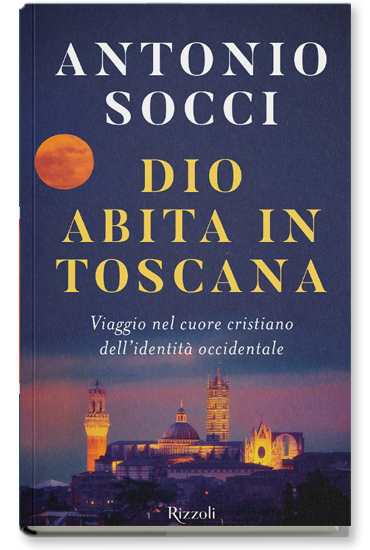LA TIRANNIA DEL CONFORMISMO 2.0
In questi tempi di pensiero uniforme e preconfezionato, sui media e nella rete, quindi nelle relazioni sociali, sembra tornata di grande attualità la canzone di Giorgio Gaber, “Il conformista”.
E’ la perfetta rappresentazione del mondo dei semicolti e dei cosiddetti intellettuali di oggi, seguiti e imitati pedissequamente da greggi che pascolano sui social e nei media:
“Il conformista
è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta
ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa
è un concentrato di opinioni
E quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire
forse da buon opportunista
si adegua senza farci caso
e vive nel suo paradiso”.
Ovviamente “il conformista” che un tempo fu “fascista” poi è diventato “marxista-leninista/ e dopo un po’ non so perché mi son trovato Americanista” (il testo dice: cattocomunista, ma lui cantando dice “americanista”).
Ma soprattutto – dice Gaber, facendo una carrellata degli ultimi decenni – è stato “un po’ sessantottista”, da qualche tempo “è ambientalista”, per un po’ è stato “come un po’ tutti socialista”, ma in sintesi oggi è “progressista,/ al tempo stesso liberista antirazzista” e pure “animalista” (non più “assistenzialista”). E naturalmente è “ottimista europeista”, “femminista” e “pacifista”.
Il genio popolare di Gaber – oltre alle trasformazioni delle idee – coglie la psicologia di questo diffusissimo tipo umano. Il conformista è uno “senza consistenza” che “s’allena a scivolare dentro il mare della maggioranza”e “vive di parole da conversazione… galleggiando”, come un pallone“gonfiato dall’informazione”, un tipo umano “che vola sempre a bassa quota in superficie/ poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato”.
La satira di Gaber si ferma qui. Si potrebbe aggiungere che “il conformista” è uno che non si fa domande che possano destabilizzarlo e quindi si scandalizza quando trova chi semina dubbi e pone interrogativi scomodi che mettono in discussione i suoi preconcetti, le sue idee convenzionali.
E qui spunta l’altro lato della medaglia del pensare conformista che è la scomunica collettiva verso il pensiero dissidente, il disprezzo verso l’eretico, l’ostilità di branco contro i non allineati (con relativa gragnuola di insulti), la demonizzazione dell’avversario trasformato in Nemico (talvolta addirittura nemico dell’umanità) e poi – spalmato dappertutto – l’odio, distillato di odio, ma ovviamente mascherato come il suo contrario, cioè come lotta contro “l’odio” che si attribuisce al Nemico.
Ci sono i “catechismi civili” da ossequiare, con i loro luoghi comuni e ci sono ormai addirittura i “dizionari politicamente corretti”, con le parole e i pensieri permessi e vietati, per convenzione sociale, per regolamento e presto perfino per legge. Oggi siamo arrivati molto in là nel regno del luogocomunismo.
All’origine però c’è sempre una sottomissione accettata, spesso per quieto vivere. La libertà comincia a morire a volte in modo impercettibile. All’inizio magari per un clima pedagogico, che diventa sottilmente intimidatorio, a cui ci si arrende, prima individualmente e poi collettivamente.
Questo ci dice un breve racconto di Dino Buzzati intitolato “La parola proibita”, che fa parte del volume “Sessanta racconti”, pubblicato da Mondadori, e che dovrebbe trovare cittadinanza nelle antologie scolastiche.
Buzzati – che è vissuto nel mondo dei giornali ed è morto nel 1972 – descrive benissimo il meccanismo che induce all’autocensura e poi alla sottomissione all’ideologia dominante.
Il protagonista del breve racconto (surreale e distopico) esordisce dicendo che “da velati accenni, scherzi allusivi, prudenti circonlocuzioni, vaghi sussurri, mi sono fatto finalmente l’idea che in questa città, dove mi sono trasferito da tre mesi, ci sia il divieto di usare una parola”.
Incuriosito va ad interrogare un amico, Geronimo, e quello conferma, ma gli spiega che non se la sente di dirgli che parola è: “io vivo in questa città da oltre vent’anni, essa mi ha accolto, mi ha dato lavoro, mi permette una vita decorosa, non dimentichiamolo. E io? Da parte mia ne ho accettate le leggi lealmente, belle o brutte che siano. Chi mi impediva di andarmene? Tuttavia sono rimasto. Non voglio darmi le arie da filosofo, non voglio certo scimmiottare Socrate quando gli proposero la fuga di prigione, ma veramente mi ripugna contravvenire alla norma della città che mi considera suo figlio… sia pure in una minuzia simile. Dio sa, poi, se è davvero una minuzia…”
Non per paura di una punizione, no, dice Geronimo: “anche se non è accompagnato da sanzione, il precetto può assurgere a tutto il suo massimo valore; siamo evoluti, noi.”
Neanche per dovere di coscienza, che ormai – spiega Geronimo – non è più intransigente come prima e si è addomesticata in “qualcosa di più tranquillo. Volgarmente lo si chiama conformismo. E’ la pace di colui che si sente in armonia con la massa che lo attornia. Oppure è l’inquietudine, il disagio, lo smarrimento di chi si allontana dalla norma”. E “questo basta. E’ una forza tremenda, più potente dell’atomica”.
Certamente esiste, aggiunge, “una geografia del conformismo. Nei paesi arretrati è ancora in fasce, in embrione, o si esplica disordinatamente, a suo capriccio, senza direttive. La moda ne è un tipico esempio. Nei paesi più moderni, invece, questa forza si è ormai estesa a tutti i campi della vita, si è completamente rassodata, è sospesa si può dire nell’atmosfera stessa: ed è nelle mani del potere”.
Come se il potere si fosse interiorizzato nelle anime. Quella “parola proibita” non è un’espressione sporca o delittuosa: “Tutt’altro. E’ una parola pulita, onesta e tranquillissima. E proprio qui si è dimostrata la finezza del legislatore”.
Il dialogo è fine e geniale, tutto da leggere. In breve, s’intuisce che la “parola proibita” del racconto – senza che mai venga espressa (rimane come spazio bianco) – è “libertà”. E si capisce che, con la parola, Buzzati intende dirci che è proibita soprattutto l’idea di libertà, la sua dimensione vissuta.
Nella “geografia del conformismo” rammentata da Buzzati, oggi, bisogna dire che perdura tuttora quello soffocante dei regimi totalitari, come la Cina comunista, ma, con il conformismo e la censura dei media e dei giganti del web (non solo nel clamoroso caso di Trump: la punta dell’iceberg), anche in Occidente si respira la pesante atmosfera illiberale di un “pensiero unico” obbligato.
Così tornano d’attualità le letture giovanili degli spiriti liberi, quando, negli anni Settanta – gli anni del dissenso eroico di Solzenicyn in Urss e gli anni della cappa ideologica marxista imposta qua da noi – si leggeva “Vivere senza menzogna” del grande scrittore russo e “Il potere dei senza potere”di Vaclav Havel, l’allora sconosciuto drammaturgo cecoslovacco che entrava e usciva dal carcere comunista e che divenne poi il primo presidente della Cecoslovacchia libera.
In entrambi questi libri risuonava lo stesso messaggio: mai essere conniventi con la menzogna per quieto vivere o per paura. Il dispotismo è un gigante dai piedi d’argilla che crolla di fronte all’inerme verità, pronunciata dagli uomini liberi.
.
Antonio Socci
.
Da “Libero”, 25 gennaio 2021