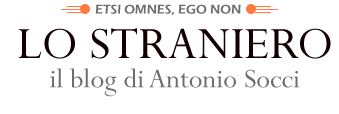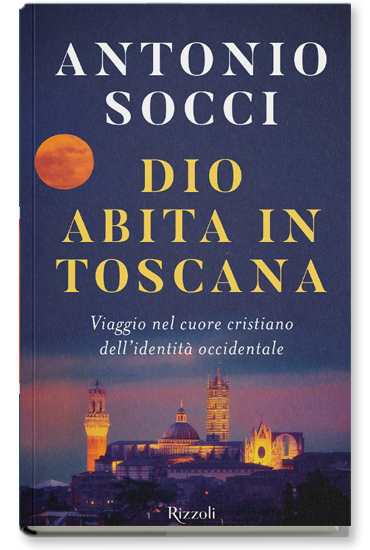LA VERITA’ (CHE NON AVETE MAI SENTITO) SU BOCCACCIO E IL DECAMERON. L’“ONESTA BRIGATA” DI GIOVANI E “L’ARMONIA CORTESE DI UN CRISTIANESIMO REALIZZATO NELLA LIBERTA’ E NELL’AMORE”, SENZA MORALISMI (NON C’E’ “NULLA DI PIU’ ITALIANO”)
Chi volesse saperne di più, su questo tema, può vedere il capitolo che ho dedicato a Boccaccio e Certaldo nel mio “Dio abita in Toscana” (Rizzoli).
+ + + +
Benedetti gli anniversari che riportano alle radici e all’identità di un popolo. Per esempio, quest’anno è il 650° della morte di Giovanni Boccaccio (1313-1375), personalità di straordinaria importanza ridotta purtroppo a una figura minore e ignota ai più.
Così come il suo capolavoro, il Decameron, è stato ridotto al film che nel 1971, all’insegna della trasgressione politico-culturale, ne ricavò Pier Paolo Pasolini (salvo scrivere nel 1975, un’“Abiura dalla Trilogia della vita” che andrebbe riletta per la sua tragicità).
Peraltro il tragico è proprio la vera (e dimenticata) cornice delle novelle del Decameron e conferma l’ispirazione dantesca di quest’opera che ebbe subito un successo strepitoso e fu il primo grande best seller.
UNA GRANDEZZA POCO CONOSCIUTA
Il nome del Boccaccio sta accanto a quelli di Dante e di Francesco Petrarca: le cosiddette tre corone che hanno “imposto” il toscano come lingua letteraria italiana (succedendo al latino). Dal Cinquecento Pietro Bembo individuò nell’autore del Decameron il modello della prosa italiana (e Petrarca per la poesia).
Boccaccio, peraltro, fece scuola anche oltre i confini perché, per esempio, “il suo influsso si fa sentire in una raccolta come I racconti di Canterbury, dell’inglese Geoffrey Chaucer”(Ferroni) e non solo, perfino nella Spagna di Cervantes.
Lo scrittore di Certaldo è il vero punto d’incontro fra Dante e Petrarca. Trasformò in scuola e movimento culturale, l’opera e le intuizioni dei due. È il vero, grande “promotore” dell’identità culturale italiana.
Infatti da una parte – su incitamento del Petrarca, che esortava al ritorno ai classici e al latino – fa nascere nel convento di Santo Spirito il primo Umanesimo fiorentino con Luigi Marsili, Coluccio Salutati e Leonardo Bruni. Dall’altra Boccaccio è il protagonista della “riabilitazione” fiorentina di Dante, il cui Poema sacro è la sua grande passione letteraria.
È lui che nel 1350, in rappresentanza del Comune, va a Ravenna (dove Dante era morto ed era sepolto), per consegnare alla figlia, suor Beatrice, una somma per riconoscenza da parte della sua città che lo aveva esiliato.
È sempre Boccaccio che, attorno al 1355, scrive il Trattatello in laude di Dante Alighieri, la più antica biografia del poeta. Ed è ancora a lui che Firenze chiede una lettura pubblica del Poema sacro.
Il 23 ottobre 1373, alla Badia fiorentina, davanti a una folla di fiorentini (forse anche i parenti di personaggi evocati nel Poema) iniziò il suo ciclo di letture pubbliche e di commento della Commedia (che fu lui a chiamare “Divina”). Si fermò al XVII canto dell’Inferno per motivi di salute e poi morì il 21 dicembre 1375 (quelle sessanta lezioni, diventarono le Esposizioni sopra la Commedia).
Era la prima volta che si leggeva un testo in volgare e non in latino. L’impressione fu grande. Fu la solenne riconciliazione con Firenze e la consacrazione del Poema dantesco verso la gloria letteraria.
Vittore Branca ha dimostrato che – oltre della venerazione di Boccaccio per Dante e per il suo capolavoro – c’è un legame profondo fra la Commedia e il Decameron e non solo per la scelta del volgare come lingua letteraria, con cui Boccaccio ha voluto compiere, nella narrativa, ciò che Dante aveva fatto nella poesia.
LO STRAVOLGIMENTO DEL DECAMERON
A partire da Francesco De Sanctis – spiega Branca – “la tradizione critica ha voluto vedere quasi costantemente nel Decameron il manifesto ideale di una nuova epoca, anzi la negazione e la beffa dell’età di mezzo”. E questo perché “è stata deviata soprattutto da due pregiudizi o meglio da due pseudo-concetti critici: dai motivi polemici anticlericali e antiromani di origine luterana […] e dalla concezione illuministica e ottocentesca, neppure oggi spenta, che opponeva a un Medioevo tutto tenebre e superstizione la grande luce dell’Umanesimo”.
Per i critici dell’Ottocento il Medioevo era sinonimo di mistica, mentre l’Umanesimo metteva al centro la terra e l’uomo: “Dante era, per questa critica, il poeta di quell’umanità tutta assorta nelle realtà trascendenti: il Boccaccio gli si opporrebbe come il cantore di quella gioia e di quell’esaltazione della vita terrena che caratterizzerebbe la nuova civiltà”. Dunque alla Commedia dantesca, “succederebbe la commedia del senso e della carne” del Boccaccio.
Ma Branca demolisce questa interpretazione perché “sotto il peso di queste concezioni manichee tutto il grandioso disegno del Decameron svaniva”. Esso ha infatti “una grandiosa architettura gotica”.
LA GIUSTA INTERPRETAZIONE
Il capolavoro del Boccaccio – spiega il critico – appare “da una parte come la tipica ‘commedia dell’uomo’ rappresentata attraverso i paradigmi più canonici alla visione cristiana e scolastica della vita, e dall’altra come una vasta e multiforme epopea della società medievale italiana, colta e ritratta nel suo autunno splendido e lussureggiante”. Perciò “non si oppone alla Divina Commedia, ma in qualche modo le si affianca e quasi la completa”.
Del resto ricorda il poema sacro con la simbologia del cento (cento canti e cento novelle) e soprattutto con quell’“orrido cominciamento” che nella Commedia è la foresta oscura dantesca e nel Decameron è quell’immenso cataclisma storico che fu la peste nera del 1348 che decimò l’Europa e anche Firenze. Fu questa tragedia che mise fine alla spensieratezza mondana del Boccaccio. Da allora egli cambiò vita e tornò a un’ardente fede religiosa.
Secondo Giuseppe Fornari “nel Decameron l’‘onesta brigata’ di giovani va a formare l’hortus conclusus che farà da cornice ai suoi cento racconti fuggendo la peste e contrapponendole l’armonia cortese di un cristianesimo realizzato, nella libertà e nell’amore con cui i mille casi della vita umana sono narrati e considerati, a inveramento di principii cristiani e cristici non offuscati da nessun moralismo. Un capolavoro che non potrebbe essere più italiano, anche se il cattolicesimo istituzionale si guarderà bene dal prenderne nota”.
Per Giulio Ferroni il loro “raccontare diventa restaurazione di un ordine, risposta allo sconvolgimento che la peste ha causato nella città; la vita della brigata, pur rivolta al piacere, si afferma infatti come coesistenza conveniente e onesta, come immagine ideale di una rinnovata dimensione civile”. Ricorda l’Allegoria del buongoverno di Ambrogio Lorenzetti.
Antonio Socci
Da “Libero”, 23 febbraio 2025